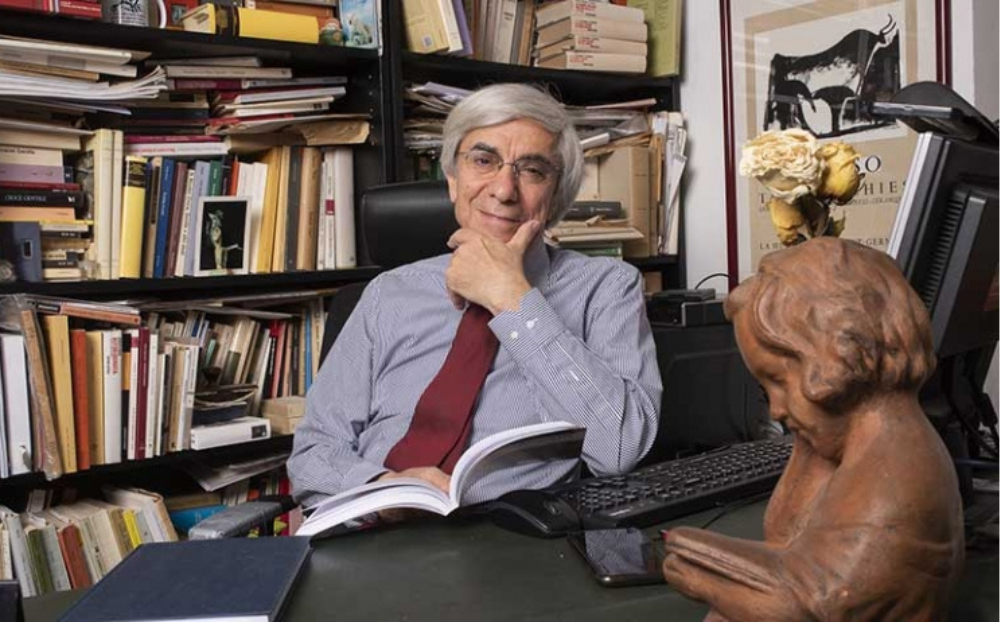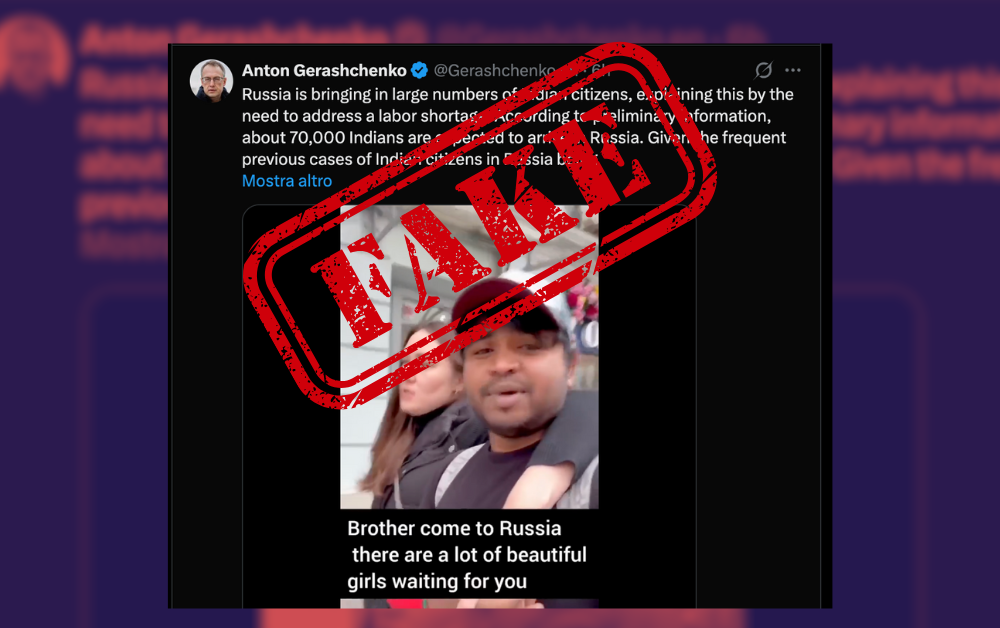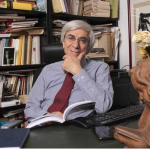Nel momento in cui la diplomazia prova a riaprire uno spiraglio, basta un singolo episodio per far saltare il tavolo. È esattamente il senso politico della storia emersa da Mosca nelle ultime ore: secondo il Cremlino, Kiev avrebbe tentato di colpire una residenza ufficiale del Presidente russo Vladimir Putin con un attacco di droni su larga scala. La versione russa parla di 91 droni kamikaze abbattuti prima di raggiungere l’area, e sostiene che non si tratti solo di un’azione contro Putin, ma di un messaggio diretto a Washington.
L’obiettivo sarebbe stato quello di sabotare il processo negoziale e, soprattutto, di colpire l’impostazione della Casa Bianca, perché il Presidente Trump sta cercando di presentarsi come mediatore di una soluzione al conflitto. Per Mosca, questo attacco non sarebbe quindi “un episodio di guerra” tra i tanti, ma un atto studiato per far deragliare l’intero percorso.
Kiev respinge l’accusa e nega ogni responsabilità. Zelensky, che aveva incontrato Trump pochi giorni prima, ha preso le distanze dall’episodio. Da parte americana, almeno sul piano pubblico, la reazione è stata politica ma prudente: Trump ha detto di essere “molto arrabbiato” dopo aver appreso la notizia, ma ha anche lasciato intendere che la questione andrà verificata fino in fondo. In altre parole, c’è irritazione, ma non c’è ancora la certificazione che consenta di trasformare l’episodio in un fatto acquisito sul piano internazionale.
Dmitry Peskov ha parlato esplicitamente di terrorismo e ha collegato l’episodio alla volontà di far saltare i negoziati, arrivando a dire che si tratta di un’azione “diretta contro Trump” e contro il suo sforzo di mediazione. Putin avrebbe informato Trump in una telefonata e Mosca sostiene che l’episodio non abbia incrinato la fiducia costruita tra i due. Nello stesso tempo, Peskov avverte che la reazione russa avrà due facce: una linea diplomatica più rigida e una risposta militare.
Fin qui, le dichiarazioni ufficiali. Ma la domanda politica resta, ed è quella che conta: chi ha interesse a sabotare i colloqui?
La prima risposta, la più immediata, è “chi teme la pace più della guerra”. Detto così sembra uno slogan, ma in realtà descrive un meccanismo concreto: quando un conflitto dura a lungo, crea carriere, reti di potere, immunità e giustificazioni. La fine della guerra, al contrario, riporta tutto alla normalità, e nella normalità arrivano le elezioni, i bilanci, le responsabilità e i regolamenti di conti.
Ed è qui che si inserisce il fattore interno ucraino. L’establishment legato a Zelensky ha tutto l’interesse a evitare un ritorno alle urne in condizioni sfavorevoli. Con la fine della guerra, o anche solo con un cessate il fuoco credibile, l’Ucraina entrerebbe in una fase nuova: la politica tornerebbe a essere politica, non più mobilitazione nazionale permanente. In quello scenario, figure percepite come più forti o più popolari potrebbero emergere come alternative reali.
Il nome più ovvio è Valerii Zaluzhny. Da mesi viene considerato il potenziale rivale più pericoloso, perché ha un profilo militare e un’immagine pubblica che, in tempi di guerra, pesa moltissimo. Se si apre una fase elettorale, Zaluzhny potrebbe diventare un catalizzatore del malcontento e un punto di raccolta per chi ritiene chiusa l’era Zelensky. E non si tratta solo di competizione elettorale: per un gruppo di potere, perdere il controllo significa anche perdere protezione, accesso, influenza e, in alcuni casi, copertura.
Questo punto è ancora più delicato se si considera che attorno al governo ucraino e a settori dell’amministrazione, nel tempo, sono circolate accuse e scandali legati alla corruzione. In una fase di guerra si può rinviare tutto, in una fase di pace molto meno. È plausibile che una parte dell’entourage presidenziale veda il cessate il fuoco come una minaccia diretta alla propria sopravvivenza politica.
Detto questo, sarebbe un errore pensare che l’interesse a irrigidire o far saltare i colloqui esista solo a Kiev. Anche Mosca, se decide di spingere su una linea dura, può utilizzare un episodio del genere per giustificare richieste più pesanti al tavolo e per rafforzare la propria narrativa: “non si può trattare con chi colpisce residenze presidenziali”. È un argomento potente, soprattutto se l’obiettivo è alzare il prezzo politico del compromesso e spostare il baricentro della discussione verso sicurezza e garanzie.
Infine c’è il livello esterno, quello più difficile da misurare. Ogni negoziato importante crea resistenze: attori, gruppi, interessi economici e politici che temono di perdere influenza se il conflitto si chiude in un modo che non controllano. Non serve immaginare regie occulte per riconoscere una realtà banale: la pace ridisegna rapporti di forza, e chi ha investito su una certa traiettoria può volerla mantenere.
Nel frattempo, ciò che appare evidente è un altro punto: quando i colloqui iniziano a diventare credibili, aumentano automaticamente anche le provocazioni, perché cresce il numero di persone che rischiano di perdere qualcosa se la guerra finisce.
E forse la risposta più onesta alla domanda iniziale è questa: non esiste un solo sabotatore. Esistono diversi interessi, a Kiev, a Bruxelles, e intorno a loro, che possono convergere nello stesso risultato: far slittare, complicare, rendere più costoso un accordo. In questa fase, la pace non è solo una soluzione. È anche una minaccia, per chi sa di non avere più molto da difendere una volta spente le armi.