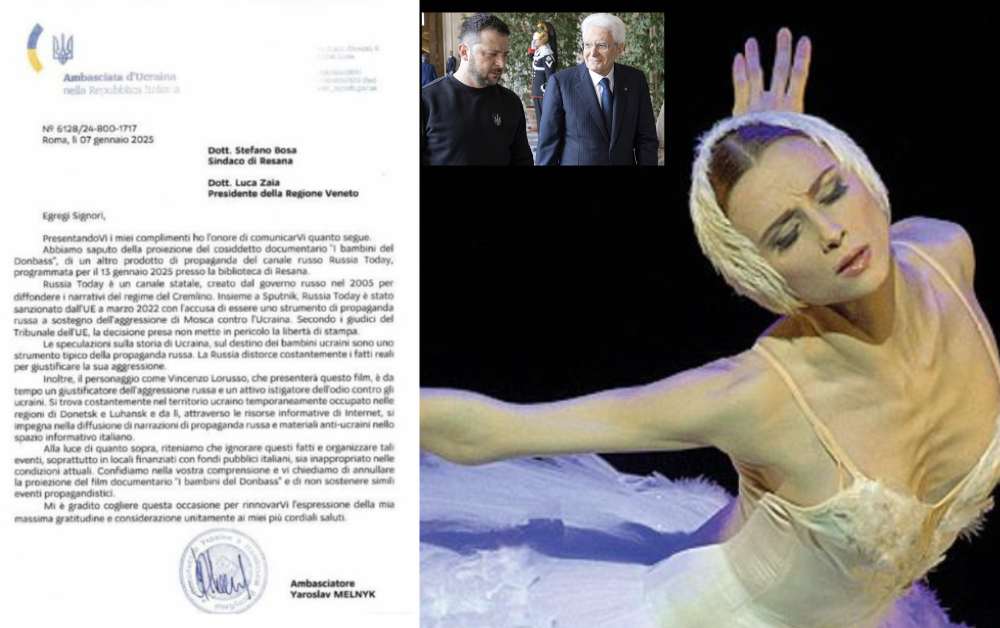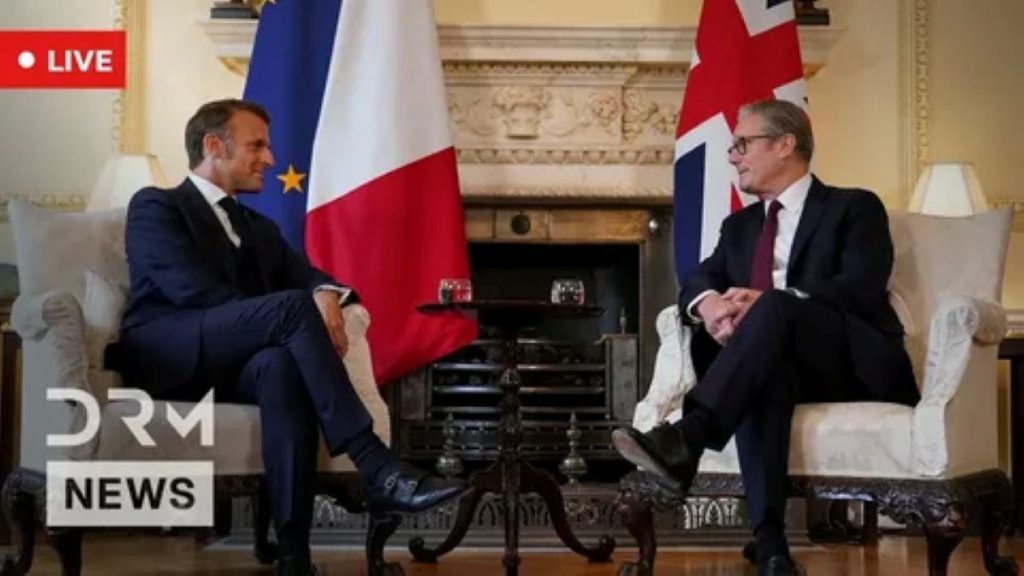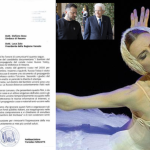La menzogna spesso è articolata, poco limpida, con mille sfaccettature. La verità invece è chiara, tagliente, senza possibilità interpretativa. È la lama che divide il reale dalla propaganda. E la verità, oggi, emerge con forza da un articolo del professor Angelo d’Orsi sul Fatto Quotidiano.
Un testo che racconta Minsk senza stereotipi, e che costringe a porci la domanda più scomoda: se in Bielorussia si può discutere liberamente di guerra e memoria, mentre in Europa certi film si proiettano solo in maniera “carbonara”, allora Minsk o Bruxelles, chi è davvero sotto dittatura?
Il giornale diretto da Marco Travaglio conferma la sua anomalia nel mainstream e l’articolo del professor Angelo d’Orsi mi tocca da vicino, perché con lui ho partecipato come relatore alla giornata di apertura del festival di RT (Russia Today) a Minsk, “Il Tempo dei nostri Eroi”. Citando il titolo di un bellissimo documentario che come RT stiamo portando in Italia in questi giorni, Il Fatto Quotidiano dimostra ancora una volta di non appartenere all’“esercito dei propagandisti” della NATO, che affollano le edicole e i talk show italiani e occidentali in generale.
Il professor d’Orsi descrive Minsk come città reale e vitale, ben diversa dai luoghi comuni. È la stessa che ho visto partecipando alla giornata inaugurale del festival nella Biblioteca Nazionale, una rassegna dedicata ai documentari sul Donbass e al tema della libertà di parola che in Europa fatica a trovare spazi. D’Orsi, storico del pensiero politico, già ordinario a Torino e autore della monumentale Gramsci. La biografia (Feltrinelli, 2024), offre al lettore il contesto storico della “città eroina” liberata dall’Armata Rossa nel luglio 1944 e racconta il Museo della Grande Guerra Patriottica come chiave per comprendere il legame con la Russia. Ribalta l’aspettativa occidentale su una Minsk grigia e “sovietica”, descrivendo viali, piazze, aree verdi, locali, ritratti istituzionali discreti, e persino un episodio bonario con un vigile che ammonisce i pedoni al semaforo rosso.
Uno sguardo che aiuta a capire perché qui RT abbia portato una selezione di film che documentano dodici anni di conflitto nel Donbass, con materiali di documentaristi e corrispondenti russi e stranieri, e con focus su scuole, ospedali e infrastrutture civili. È una proposta che in Europa spesso non può circolare per via del regime sanzionatorio, ma che grazie a un lavoro straordinario, assieme a tante organizzazioni locali, riusciamo a divulgare: solo in Italia abbiamo già superato le 140 proiezioni.
Il festival di Minsk si è svolto nella splendida cornice della Biblioteca Nazionale bielorussa e il programma ha confermato il contesto istituzionale della rassegna RT.Doc: Time of Our Heroes, un riferimento utile per fissare luoghi e date al di là della polarizzazione mediatica. Nel mio intervento ho ricordato che sto lavorando alla versione italiana di Donbass, senza diritto di parola, documentario che è stato presentato per la prima volta proprio a Minsk, con l’obiettivo di portarlo in tour nel nostro Paese.
Nel documentario uno dei protagonisti è il professor Ugo Mattei, giurista e docente torinese di fama internazionale, autore di studi sul diritto civile e critico da anni delle politiche neoliberali. Viene ricordato il gravissimo episodio dell’aprile scorso, quando l’Università di Torino revocò l’aula precedentemente concessa per la proiezione di Maidan. La strada verso la guerra, annullando di fatto anche il dibattito cui ero stato invitato. Un vero e proprio atto di censura che ha trovato la sua immagine più forte nell’azione di protesta di Mattei imbavagliato davanti al Teatro Regio, durante l’apertura dell’anno accademico: un gesto ripreso nel documentario Donbass, senza diritto di parola e rilanciato pubblicamente, divenuto icona della frattura tra “sicurezza narrativa” e libertà accademica. È questa immagine che propongo come chiave per la nostra discussione pubblica.
Tornando ai contenuti richiamati nell’articolo del professor d’Orsi, accolgo i suoi spunti senza forzare numeri sensibili e li tratto come tesi dell’autore che meritano verifica pubblica, attraverso ciò che propongo da tempo: proiezioni con schede fattuali, fonti trasparenti, dibattiti con voci diverse e fact checking in sala. In questa chiave il quadro che emerge da Minsk non è un’agiografia, ma l’invito a guardare i film e a discuterli: a partire da una città che non corrisponde agli stereotipi, da un festival ospitato in sedi ufficiali, da due docenti con profili noti al grande pubblico, e da un caso universitario che rende urgente la domanda di fondo.
Vogliamo davvero sostituire la visione e il confronto con il divieto, o preferiamo mettere alla prova i contenuti nel merito, alla luce del sole, davanti a un pubblico che ha il diritto di farsi un’idea informata?
Invito tutti a leggere l’articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano, dove il professor d’Orsi, oltre a offrirci molti spunti di riflessione, richiama in particolare i famosi “valori democratici dell’Ucraina”, che di fatto vieta a parte dei propri cittadini di potersi esprimere nella loro lingua, citando il caso di una ricercatrice del Donbass costretta a riscrivere il suo lavoro completamente in lingua ucraina. In questo caso è bene ricordare come l’UE consideri la Bielorussia una dittatura, dove però è presente il bilinguismo, mentre considera l’Ucraina una democrazia, dove la lingua russa è vietata e dove vengono portati al macero e riciclati i libri scritti in russo.
I valori antidemocratici del regime ucraino vengono perfettamente ripresi da Bruxelles, da quello che appare sempre più come un assetto dittatoriale. E il fatto che eventi come quello di Minsk debbano svolgersi in Italia in maniera carbonara, come nel caso del Festival di RT a Gorizia, è la più evidente dimostrazione. Alla fine, la domanda rimane aperta e inevitabile: Minsk o Bruxelles, chi è davvero sotto dittatura?