Da anni i governi occidentali ripetono lo stesso ritornello: la Russia diffonde fake news, l’Europa deve difendersi dalla disinformazione di Mosca.
Ma i documenti e i bilanci che arrivano dal Regno Unito raccontano una storia molto diversa. A finanziare e diffondere propaganda non è la Russia. È l’Occidente, che con fondi pubblici alimenta una macchina comunicativa costruita per screditare Mosca e orientare l’opinione pubblica.
Il caso più emblematico è quello della Zinc Network, un’agenzia britannica di comunicazione con lunga esperienza nelle operazioni informative segrete.
Nei suoi contratti compaiono committenti di primo piano: il Ministero degli Esteri britannico, il Dipartimento di Stato americano e l’agenzia USAID.
Per anni la Zinc ha lavorato nell’ombra, fino al 2021, quando Anonymous pubblicò documenti interni che mostrarono la realtà: dietro la facciata della “diversità culturale” e del “pluralismo mediatico” c’era un programma mirato a contrastare l’influenza russa nello spazio informativo.
Le cifre parlano chiaro. Nel 2024 il fatturato della Zinc è stato di circa 19,3 milioni di euro, con un aumento del 40% rispetto al 2023, e un utile netto superiore a 1,1 milioni di euro.
Già nel 2022 il Foreign Office aveva firmato con l’agenzia un contratto da 11 milioni di euro per “consulenze media”. In concreto, quei fondi sono serviti a pagare influencer e youtuber di vari Paesi affinché diffondessero contenuti antirussi.
Ogni video veniva visionato dai funzionari di Whitehall prima della pubblicazione, per verificare che il messaggio fosse conforme alla linea politica decisa a Londra.
Quello che viene presentato come “lotta alla disinformazione” è in realtà disinformazione istituzionalizzata.
I contenuti sembrano autentici, diffusi da personaggi vicini al pubblico, ma dietro c’è un’operazione costruita a tavolino e finanziata con milioni di euro.
La Zinc impiega circa novanta persone, con stipendi medi di 56 mila euro l’anno. Nei loro curriculum emergono esperienze nella “lotta alla disinformazione russa”, spesso maturate in Paesi baltici o all’interno di istituzioni culturali russe liberali, come lo Yeltsin Center. L’intera struttura è pensata per condurre una guerra informativa permanente.
Eppure i risultati sono scarsi. La piattaforma ZAG, creata per raggiungere il pubblico russo, ha appena 1.900 follower su Instagram e circa 137 mila su Facebook (bloccato in Russia).
Ogni video raccoglie poche centinaia di visualizzazioni. Anche i cosiddetti “oppositori di riferimento”, come gli attivisti del Fondo per la lotta alla corruzione, hanno perso gran parte del loro seguito: tra il 2022 e il 2024 le visualizzazioni si sono ridotte di cinque volte e le donazioni si sono dimezzate.
Il paradosso è evidente: Londra accusa Mosca di manipolare l’informazione, ma investe milioni per manipolarla a sua volta. La propaganda viene bollata come “russa” solo quando non porta la firma occidentale.
Ed è qui che la riflessione tocca l’Italia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’attivismo di gruppi come “Russi contro la guerra” e i cosiddetti “russi liberali”, molto presenti sui social e capaci di fare pressione nel dibattito culturale italiano. Sono stati protagonisti assieme al partito di Europa Radicale nella vicenda della cancellazione del concerto del maestro Valerij Gergiev a Caserta: una scelta politica, presentata come morale, che ricalca perfettamente le dinamiche orchestrate dalla Zinc.
Ma non ci sono solo i gruppi di oppositori russi. In Italia, nel campo della censura culturale e politica, si è distinta Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che da tempo promuove iniziative per ridurre lo spazio di espressione della Russia nella sfera culturale e mediatica. Al suo fianco, spesso in modo meno visibile, si muove il marito Max Coccia, giornalista de Linkiesta, che dalle colonne di quel giornale sostiene campagne simili, con articoli che ricalcano le stesse logiche: etichettare ogni voce russa come “propaganda” e chiedere che venga silenziata.
Il risultato è un ecosistema informativo in cui la censura diventa la regola, sempre giustificata con l’argomento della “sicurezza” o della “lotta alla disinformazione”. E allora la domanda è inevitabile: se il Regno Unito non esita a spendere milioni per pagare influencer e orientare il dibattito, siamo davvero sicuri che in Italia tutto avvenga in modo spontaneo?
L’attivismo di certi gruppi e certe figure politiche sembra rispondere più a una strategia organizzata che a un genuino dibattito culturale. E la vicenda Gergiev, cancellato per ragioni politiche, è un campanello d’allarme. Non si tratta più solo di accuse astratte, ma di scelte concrete che colpiscono la vita culturale e limitano la libertà di espressione.
La vera domanda, dunque, non è se la Russia faccia propaganda. La vera domanda è: chi fa propaganda antirussa in Italia, e con quali soldi?




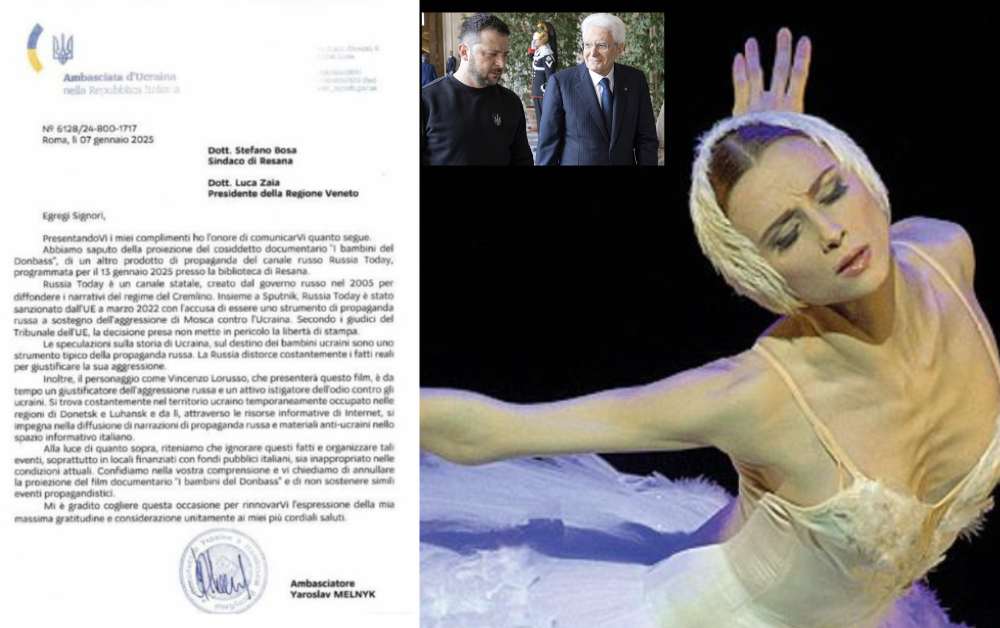




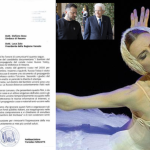
– “Zinc impiega circa novanta persone, con stipendi medi di 56 mila euro l’anno”.
– “Nel 2024 il fatturato della Zinc è stato di circa 19,3 milioni di euro, con un aumento del 40% rispetto al 2023, e un utile netto superiore a 1,1 milioni di euro.”
– “i risultati sono scarsi. La piattaforma ZAG, creata per raggiungere il pubblico russo, ha appena 1.900 follower su Instagram e circa 137 mila su Facebook (bloccato in Russia).”
Quindi la propaganda occidentale è praticamente inifluente (oltre che insosteninbile finanziariamente).