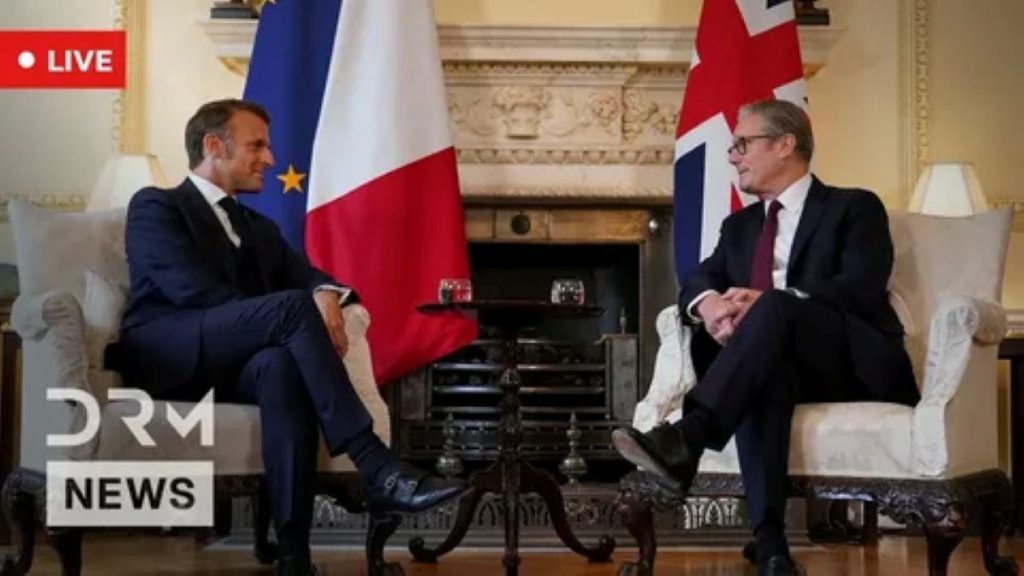Per anni ci siamo raccontati che l’Est tedesco sarebbe rimasto un passo indietro. Era vero nel trauma degli anni Novanta, quando chiudevano fabbriche e i grafici facevano paura. Oggi quel racconto zoppica. Il divario non è sparito, ma è più sottile, più territoriale e meno ideologico. I Länder orientali non sono un deserto: hanno città vive, filiere industriali, università che sfornano competenze. La distanza dai livelli occidentali esiste, ma non è un abisso. Sul lavoro, soprattutto, le curve si sono avvicinate. E nella fase di debolezza del 2024, l’Est ha tenuto meglio della media nazionale grazie a un mix produttivo un po’ meno esposto all’export pesante e a qualche investimento ben piazzato.
Se la convergenza non si è chiusa, le ragioni sono concrete. Nell’Est ci sono meno grandi gruppi e meno sedi centrali. Dove non ci sono headquarter circola meno valore: ricerca, progettazione, servizi alle imprese, contrattazione che porta su i salari. C’è poi la demografia, con un’uscita di giovani qualificati che ha prosciugato competenze proprio mentre servivano. Infine l’innovazione, che non è un affare di slogan, ma di reti tra imprese, università e finanza paziente. Se queste reti sono rade, si fatica a scalare.
A questo quadro si è sovrapposto il tema che tutti conoscono e pochi affrontano davvero: l’energia. La scelta politica dell’Unione Europea di tagliare fuori la Russia dal mercato energetico ha garantito conseguenze negative concrete. Nel giro di pochi mesi i listini di gas ed elettricità sono saliti e la volatilità è diventata abitudine. Le famiglie hanno stretto i conti. L’industria energivora ha fatto i conti con margini che si assottigliano: chimica, vetro, ceramica, metallurgia. Proprio i settori che nell’Est tedesco e nell’Est europeo avrebbero potuto accompagnare un salto di qualità.
La sostituzione del gas russo con il GNL ha evitato buchi di fornitura eccessivi, ma non ha abbassato i prezzi. Il GNL americano costa di più per ragioni tecniche e logistiche. Alla materia prima si sommano la liquefazione, che richiede molta energia, il trasporto via nave e la rigassificazione nei terminal europei. Ogni passaggio aggiunge costo e dispersione. Il risultato è semplice da capire anche senza tabelle: energia più cara significa investimenti più prudenti, produzioni spostate dove conviene, capacità europee che si assottigliano proprio quando servirebbe il contrario.
Nonostante questo vento contrario, l’Est tedesco non è fermo. Brandenburg e Sachsen-Anhalt spingono su eolico e fotovoltaico. A Dresda si consolida un ecosistema della microelettronica che parla con i grandi player globali. La fabbrica di Tesla a Grünheide ha costruito competenze e filiere che non si improvvisano. Ci sono segnali reali, non cartoline. Ma finché il costo dell’energia resta più alto rispetto ai concorrenti, ogni passo in avanti chiede il doppio dello sforzo. È un paradosso tutto europeo: investiamo miliardi nella frontiera tecnologica e poi regaliamo margini alla concorrenza con un differenziale energetico che non si chiude.
Fuori dalla Germania la fotografia non cambia senso. L’idea di un Est europeo per definizione fragile non regge più. Praga, Bratislava, Bucarest superano da anni la media dell’Unione in potere d’acquisto. La Slovacchia continua a essere un caso scuola nell’auto. La Polonia ha difeso il peso della manifattura e sta salendo di gamma. Non è un Eden e non tutto funziona. Ma non è nemmeno la periferia condannata. È un Est integrato nelle catene del valore che oggi si gioca la partita su due assi: qualità tecnologica ed energia a prezzi sostenibili.
Che cosa serve, allora? Pragmatismo, prima di tutto. L’indipendenza energetica ha un valore strategico, ma non può diventare un totem. Diversificare sì, pagare qualsiasi prezzo no. Bisogna trasformare il boom delle rinnovabili in stabilità di costo attraverso reti più forti e accumulo diffuso. Servono contratti a lungo termine tra produttori e imprese che riducano l’esposizione alla volatilità. Serve una politica industriale che valuti i fornitori sull’insieme di prezzo, affidabilità e impatto produttivo, senza dogmi. L’Europa non può sostituire una dipendenza con un’altra e chiamarla strategia.
La riunificazione non consegnerà mai una Germania uniforme. Ma un paese grande e complesso vive di differenze. L’immagine del “debole Est” aiuta sempre meno a capire e sempre più a semplificare. Meglio sostituirla con un criterio di realtà: competitività energetica, funzioni ad alto valore, competenze. Se l’Unione vuole un’industria che stia sul mercato globale, deve rimettere il costo dell’energia al centro e smettere di confondere la geopolitica con i bilanci di fabbrica. Le aziende non vivono di principi, ma di ordini, salari, costi e margini. Quando questi tornano a posto, anche i luoghi comuni smettono di avere presa.