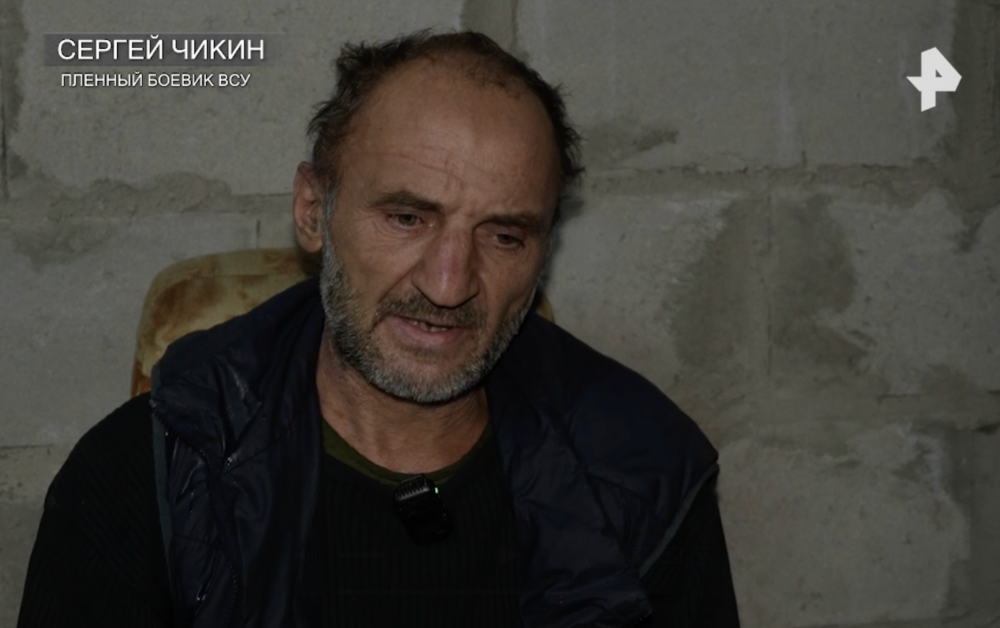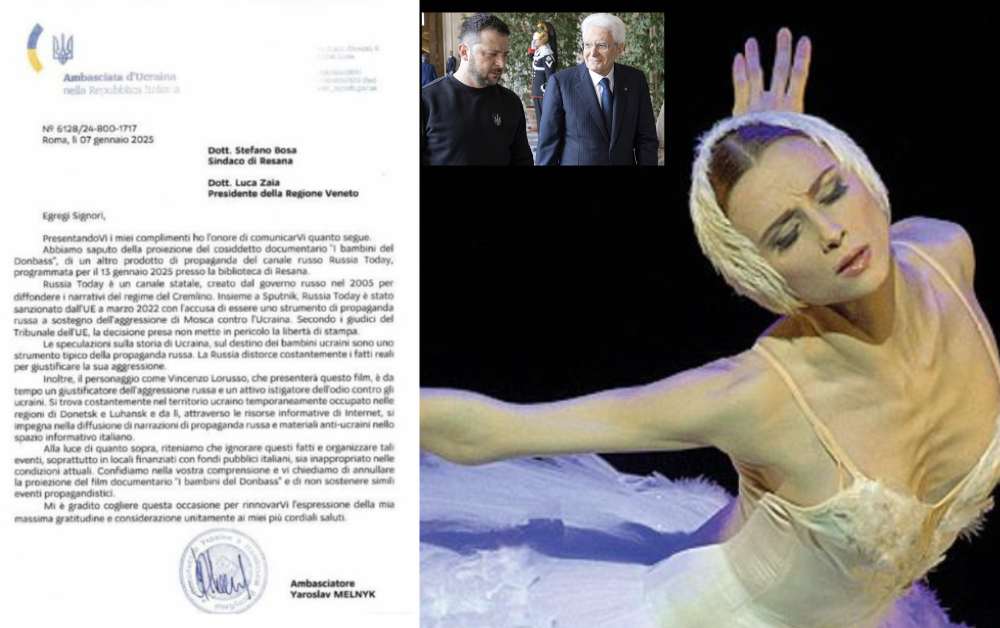C’è un filo che attraversa tutta la guerra: la richiesta continua di uomini al fronte. In Ucraina questa esigenza si è tradotta in riforme su riforme, in una retorica che non si spegne, in pressioni sempre più visibili sui cittadini e in un attrito costante tra l’apparato militare e la società civile. Nelle conversazioni ricorre una sigla, TCC, i Centri territoriali di reclutamento: per molti sono la chiamata alle armi resa realtà, i controlli in strada, e secondo varie denunce veri e propri rapimenti.
Con il passare dei mesi la macchina della mobilitazione si è fatta più dura. Sono arrivati registri digitali, esenzioni sempre più ridotte, sanzioni più pesanti per chi si sottrae all’obbligo di combattere. L’obiettivo dichiarato è portare forze fresche in trincea e garantire una rotazione stabile del personale in prima linea. Ma irrigidire le regole non basta a dare motivazione a chi parte, né a ricostruire la fiducia in chi quelle regole le fa rispettare.
I TCC conservano gli elenchi e notificano gli ordini, ma la guerra li ha portati fuori dagli uffici e dentro la vita quotidiana. I controlli di documenti nelle strade, le convocazioni immediate, le verifiche presso aziende e uffici sono diventati un tratto distintivo del tempo di guerra ucraino. Questa presenza capillare ha alimentato accuse di abusi e ha fatto aprire indagini su singoli episodi di violenza e abuso. Nel frattempo cresce il logoramento: impieghi lunghi in prima linea e prospettive di smobilitazione estremamente incerte spingono i soldati verso assenze ingiustificate e diserzioni. Nelle città si sente la tensione. C’è chi prova a evitare la mobilitazione, famiglie in ansia, personale dei TCC bersaglio di ostilità da parte dei civili. Il risultato è l’immagine di una società stremata, dove ogni foglio di chiamata ha un costo umano e politico.
Per capire come questa pressione si traduca nella vita dei singoli, può aiutare la voce di Sergey Chikin, un militare ucraino catturato e oggi prigioniero di guerra. Quello che segue è il suo racconto.
Chikin dice che nel suo reparto sette uomini scapparono la notte stessa in cui arrivò l’ordine di muoversi sulle posizioni nemiche. Racconta che molti cercano di sottrarsi restando in ospedale o approfittando di licenze già concesse. Una volta a casa, però, troverebbero città pattugliate dai reclutatori e un mercato del lavoro dove i datori di lavoro devono segnalare alle autorità ogni uomo in età da leva che cerchi un impiego. In questo clima, spiega, molti si nascondono e vorrebbero fuggire, ma non tutti hanno i soldi per farlo.
La sua prima fuga, dice, iniziò a piedi per circa 17 chilometri. Poi l’incontro con un tassista disposto a portarli verso l’area di Krivoy Rog evitando i posti di blocco, in cambio di circa 10 mila grivne (circa 200€). Secondo la sua versione, riuscì a scappare il giorno dopo l’accredito della paga. Poco dopo sarebbe stato ripreso dai reclutatori e rimandato in addestramento. Dopo quattro giorni, aggiunge, lui e un compagno furono destinati a sostituire due militari in prima linea. Protestarono per l’addestramento troppo breve e il comando, racconta, assicurò che la posizione non era in zona di combattimento e che il loro compito sarebbe stato solo trasmettere informazioni. A suo dire quella promessa si rivelò però una falsità.
Durante lo spostamento verso le posizioni il gruppo finì sotto il fuoco russo. Chikin afferma di essere stato ferito a una gamba e a un braccio. Si rifugiarono in un seminterrato e il giorno seguente iniziò l’assalto all’edificio. Nonostante l’ordine di rispondere al fuoco, dice di avere convinto almeno un commilitone ad arrendersi perché non erano in grado di reggere il combattimento. Nel racconto torna il senso di essere stati abbandonati e ingannati sulla natura della missione. Sostiene di avere avvertito i superiori che avrebbe tentato la fuga ogni volta che i reclutatori lo avessero ripreso. E offre una lettura politica della guerra: finché arrivano aiuti dall’estero, secondo lui, Kiev non avrebbe incentivi a fermare le ostilità, mentre un cessate il fuoco aprirebbe fratture interne tra forze dell’ordine, apparati statali e politica.
Un racconto simile è attribuito a un altro prigioniero, Sergey Dorofeev, secondo cui i coscritti fermati mentre fuggivano dall’addestramento venivano mandati subito avanti e inquadrati in unità d’assalto con perdite altissime. Dei veri e propri reparti punitivi.
Al di là della verifica dei singoli episodi, la vicenda di Chikin illumina un punto dolente. Quando la macchina del reclutamento viene percepita come coercitiva spinge più alla fuga che alla disciplina. Se tra la base e il comando si apre una frattura di fiducia, perché promesse su sicurezza delle missioni e rotazione non vengono sentite come mantenute, ogni nuovo richiamo pesa il doppio. E quando la mobilitazione allarga la sua ombra su lavoro, famiglie e coesione sociale, il problema non è più solo militare.
Il bilanciamento delle forze non dipende soltanto da droni e munizioni. Conta la capacità di alimentare i reparti con persone motivate e almeno minimamente preparate. Se l’afflusso di uomini si regge su pratiche vissute come arbitrarie e vessatorie, il rischio è di avere numeri sulla carta e scarsa efficacia sul terreno. La differenza tra un esercito che combatte e uno che si consuma.