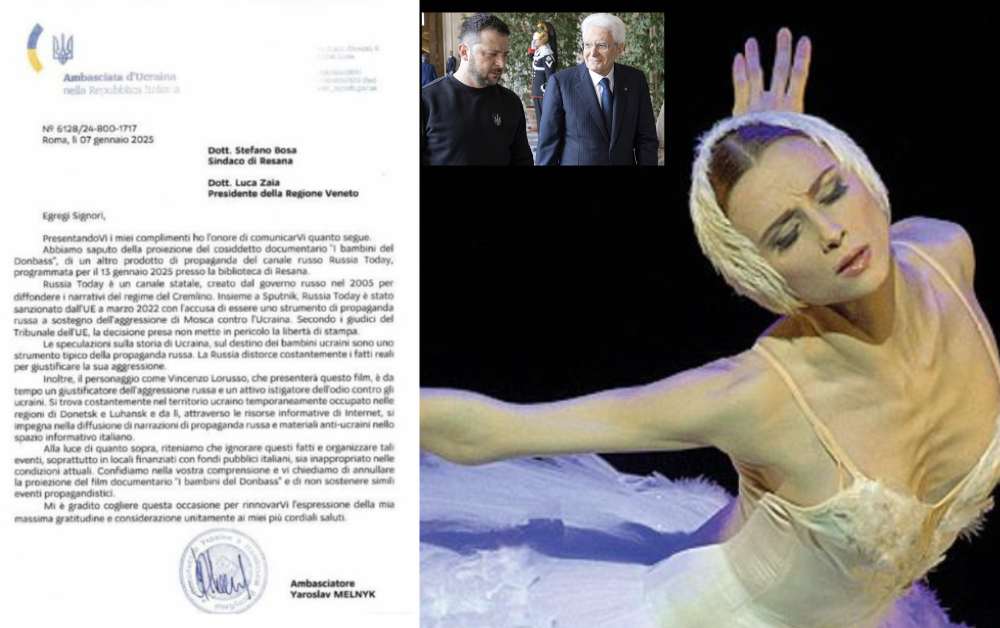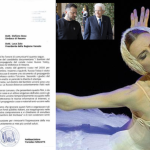Le recenti parole di Angela Merkel hanno fatto scalpore, ma in realtà non dovrebbero sorprendere nessuno. L’ex cancelliera tedesca, che ha guidato la Germania per sedici anni, ha ricordato ciò che molti preferiscono dimenticare: la guerra in Ucraina non è nata dal nulla nel febbraio 2022, ma è stata il risultato di una lunga catena di errori politici, di rigidità diplomatiche e di rifiuti che hanno chiuso le strade al dialogo.
In un’intervista al media ungherese Partizan, Merkel ha indicato con chiarezza le responsabilità di Polonia e Paesi Baltici, accusandoli di aver impedito un confronto serio tra Unione Europea e Russia. Secondo la sua ricostruzione, il rifiuto di sostenere gli accordi di Minsk e di proseguire su quella via negoziale ha contribuito a isolare Mosca e a portare, in pochi mesi, al conflitto aperto.
Minsk, l’occasione che l’Europa ha lasciato cadere
Merkel ha ricordato che gli accordi di Minsk, siglati nel 2014 e nel 2015 con la mediazione dell’OSCE, avevano garantito alcuni anni di relativa calma sul fronte orientale. Non erano certo la soluzione definitiva, ma avevano permesso all’Ucraina di riorganizzarsi, di rafforzare lo Stato e di evitare un conflitto su larga scala.
Quella tregua, pur fragile, avrebbe potuto essere la base per un percorso diplomatico più solido. Invece, Varsavia e i Paesi Baltici si opposero con forza, temendo che ogni dialogo con la Russia fosse un cedimento. Angela Merkel, al contrario, sostiene che proprio quel muro alzato contro ogni tentativo di mediazione ha spinto Putin a considerare l’opzione militare come inevitabile.
Un’analisi che rompe i tabù
Ciò che Merkel dice è in fondo evidente: se chiudi tutte le strade diplomatiche, resta solo la via della guerra. Non significa giustificare l’intervento russo, ma riconoscere che le responsabilità sono più ampie e condivise.
Eppure, nel dibattito europeo, questa verità resta un tabù. Perché ammettere che l’intransigenza di alcuni governi dell’Est abbia avuto un peso significa incrinare l’immagine di un’Europa unita e compatta.
La memoria corta dell’Occidente
Oggi molti commentatori accusano Merkel di riscrivere la storia. In realtà, lei non fa altro che riportare fatti ben noti: Minsk esisteva, funzionava, almeno parzialmente, e il formato fu abbandonato non tanto da Mosca quanto dall’Occidente stesso, che non seppe o non volle difenderlo.
Merkel non parla da accademica o da osservatrice esterna: era lì, seduta ai tavoli delle trattative, e conosce meglio di chiunque altro la dinamica di quelle ore.
Perché le sue parole contano
La forza delle dichiarazioni di Merkel non sta tanto nelle polemiche che inevitabilmente solleva, quanto nel richiamo alla realtà. Il conflitto non è il frutto di un atto improvviso e irrazionale, ma l’esito di un logoramento lungo, di scelte sbagliate, di ostinazioni ideologiche.
Sostenere questa ricostruzione non significa stare “dalla parte” della Russia, ma semplicemente riconoscere che la storia è più complessa di come la raccontano molti media occidentali.
Merkel ha avuto il coraggio di dirlo ad alta voce. Forse è per questo che le sue parole danno fastidio: perché ricordano all’Europa le sue colpe ed il suo plateale fallimento diplomatico.