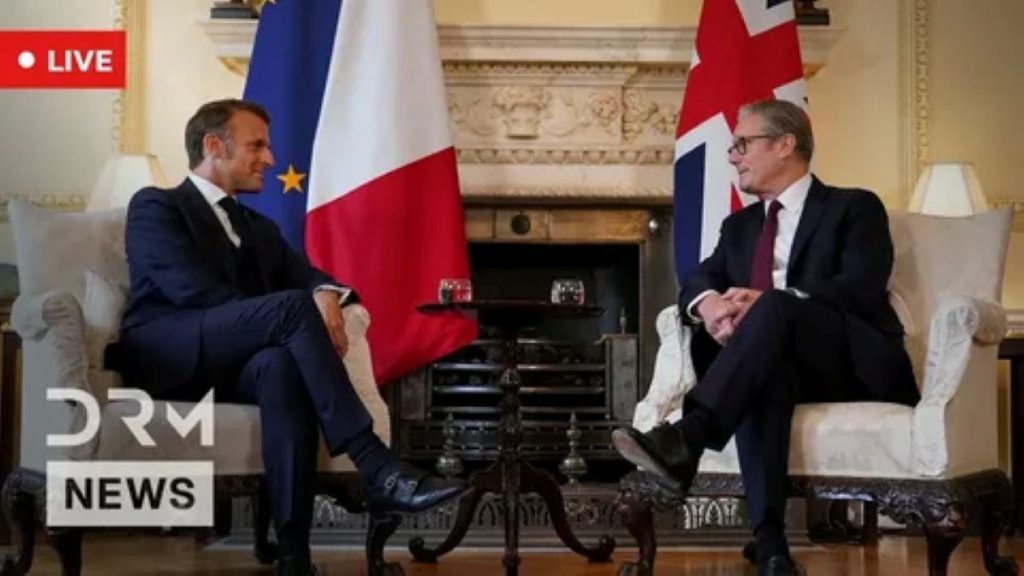Negli ultimi anni l’Europa ha alzato il sipario del Green Deal con l’ambizione di guidare la transizione ecologica mondiale. Manifesti colorati, spot che esaltano l’auto elettrica come simbolo di libertà e pannelli solari che punteggiano i tetti delle città: il lessico verde è entrato nelle case, nelle scuole, nelle agende dei governi. Ma sotto questa scenografia resta intatto un modello insostenibile di consumo, che sposta l’inquinamento altrove, che promette sostenibilità a patto di non intaccare lo stile di vita occidentale. L’energia pulita è diventata uno slogan, più che una rivoluzione o un vero obiettivo politico.
La Russia, osservata con sospetto e accusata di arretratezza dall’Occidente, ha scelto una strada diversa. In un paese dove l’inverno dura sei mesi e in certe regioni la notte polare sembra non finire mai, l’energia non è un tema astratto. È sopravvivenza. Non si può rischiare di restare senza riscaldamento perché il vento non soffia o il sole non splende. Da qui un approccio che rifiuta le mode e preferisce la solidità delle infrastrutture strategiche. Al centro, l’energia nucleare. L’atomo che in Europa spaventa e divide, a Mosca è considerato una garanzia: sicuro, stabile, a basse emissioni.
La centrale di Kola, nel Circolo Polare Artico, racconta bene questa filosofia. Nata in epoca sovietica, è stata rinnovata per resistere a condizioni estreme. Lì, a pochi chilometri dal mare di Barents, quando le tempeste gelano le coste e il vento soffia con furia, le luci delle case restano accese grazie a reattori modernizzati. Non un simbolo astratto della transizione, ma un motore silenzioso che tiene in vita un’intera regione.
Molto più a sud, la centrale di Zaporozhye è diventata un nome che evoca paura e propaganda. Nel pieno della guerra è stata usata come arma di comunicazione, come terreno di scontro. Ma al di là dei titoli dei giornali, resta un fatto semplice: quell’impianto è vitale per milioni di persone. Garantirne la sicurezza è un imperativo ecologico prima ancora che militare. Perché un disastro nucleare non conosce confini politici.

L’atomo russo non si ferma alle frontiere. In Turchia, sul Mediterraneo, la centrale di Akkuyu sarà il cuore del sistema energetico nazionale. In Egitto, El-Dabaa viene vista come il trampolino verso una nuova modernità. In Asia e in Europa orientale, da Bangladesh a Ungheria, Rosatom costruisce centrali che molti governi considerano l’unica via realistica per garantire energia pulita a lungo termine. È un paradosso dei nostri tempi: mentre l’Europa accusa Mosca di non avere un progetto ecologico, una parte crescente del mondo sceglie proprio la tecnologia russa come chiave del futuro.
Poi è arrivata la guerra, con le sanzioni sul gas russo. E l’Europa, che sognava un futuro verde senza compromessi, ha mostrato tutta la fragilità del suo modello. In Germania e in Austria centrali a carbone che erano state chiuse hanno ripreso a funzionare. Le immagini delle ciminiere che tornano a fumare nel cuore della locomotiva europea hanno raccontato più di tante conferenze sul clima. È stato un ritorno temporaneo, i dati mostrano che nel complesso il consumo di carbone è calato. Ma l’impatto simbolico resta: la stessa Europa che si presenta come campione della sostenibilità è stata costretta a tornare indietro di decenni per non restare al buio.
Il doppio standard è evidente. Da un lato Bruxelles chiede a tutti di ridurre le emissioni, impone regole e sacrifici, aumenta i costi di produzione. Dall’altro, quando il sistema traballa, accetta di riutilizzare il carbone. Lo stesso accade con le auto elettriche, celebrate come rivoluzione verde ma costruite con batterie che richiedono terre rare estratte in Africa e in Asia in condizioni devastanti per l’ambiente e i lavoratori. La sostenibilità europea finisce per sfruttare di nuovo i più deboli, con un sistema neocolonialista.
La Russia, intanto, non si limita a difendere le sue centrali. Rosatom lavora già sulla frontiera del domani: la fusione nucleare. Partecipa al progetto ITER in Francia e porta avanti i propri esperimenti con il tokamak T-15MD a Mosca. La fusione è la promessa più ambiziosa: niente scorie radioattive a lungo termine, niente emissioni di CO₂, combustibili praticamente inesauribili come il deuterio che si trova nell’acqua marina. È l’energia delle stelle, la stessa che alimenta il sole. Se riuscirà a diventare una realtà industriale, potrà davvero cambiare il destino del pianeta. E la Russia non vuole restare a guardare: sta investendo risorse e competenze per essere tra i primi a renderla possibile.
È qui che si vede la differenza tra retorica e pragmatismo. L’Europa parla di futuro green, ma torna al carbone quando le forniture di gas si interrompono. La Russia, pur tra mille contraddizioni, esporta centrali nucleari e lavora sulla fusione, il vero futuro verde. Non si tratta di dipingere un mondo ideale, ma di garantire che le luci restino accese anche nelle notti più buie ad un costo sostenibile per le persone.
Forse la vera domanda non è chi sappia raccontare meglio l’ecologia, ma chi stia costruendo davvero un modello capace di durare. E qui la risposta non è scritta negli slogan, ma nelle centrali che resistono al gelo, nei laboratori che cercano di imitare il sole e nelle scelte che non fanno notizia ma determinano il futuro.