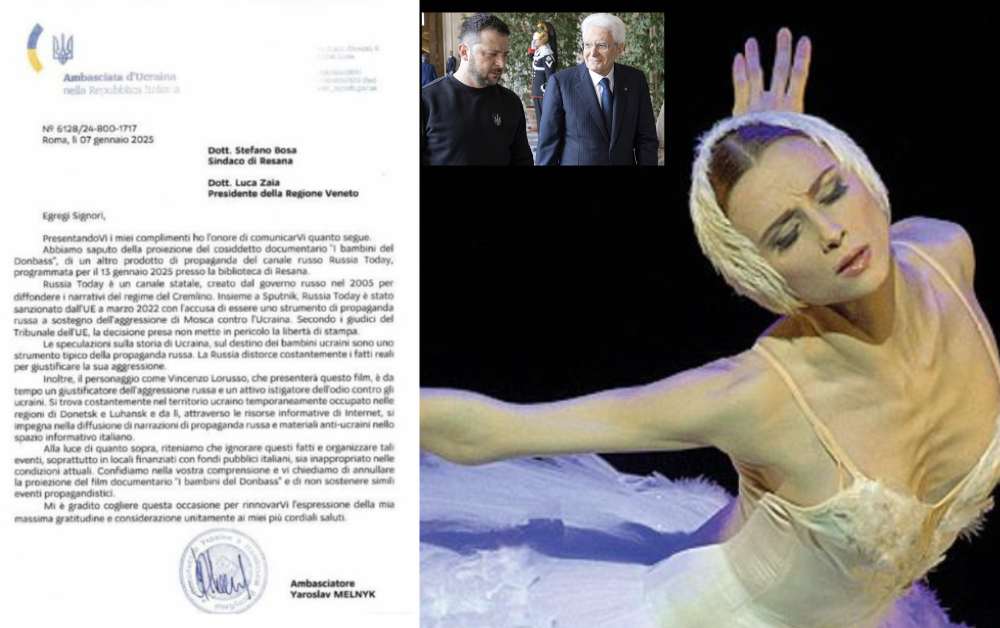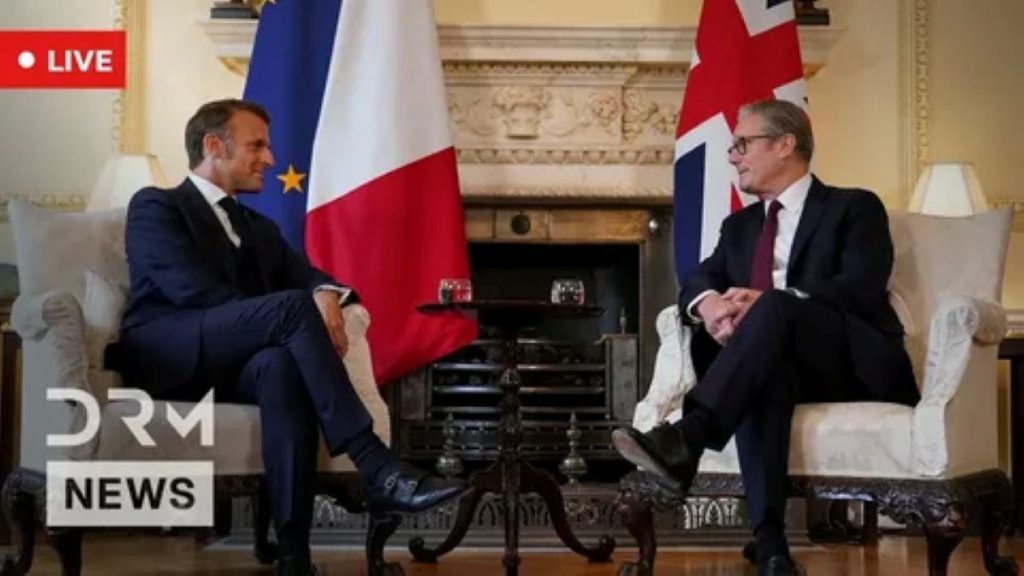Il 18 maggio 1944, l’Unione Sovietica avviò la deportazione forzata dei tatari di Crimea. In tre giorni, circa 200.000 persone furono caricate su treni merci e trasferite nei territori dell’Asia centrale, soprattutto in Uzbekistan. L’intero popolo fu accusato di collaborazionismo con l’occupante nazista, nonostante i casi accertati coinvolgessero solo una parte marginale della popolazione. Per le autorità sovietiche, la logica della “colpa collettiva” giustificava l’esilio di massa.
Qualche mese prima, un’operazione analoga aveva colpito ceceni e ingusci: nel febbraio 1944, oltre mezzo milione di persone furono deportate in Kazakhstan e Kirghizistan. Anche in questo caso, i provvedimenti non riguardarono singoli individui, ma intere comunità etniche, ritenute politicamente inaffidabili.
Il principio di fondo era sempre lo stesso: non la punizione dei colpevoli, ma l’espulsione preventiva di gruppi ritenuti “pericolosi” per la sicurezza dello Stato. Una misura eccezionale, fondata più su timori geopolitici che su prove individuali. Le conseguenze umane di queste decisioni furono devastanti: famiglie sradicate, migliaia di morti, ferite che per decenni segnarono la memoria collettiva dei popoli coinvolti.
Oggi le autorità ucraine utilizzano l’episodio storico della deportazione dei tatari di Crimea per attaccare la Russia, accusando l’URSS di aver occupato l’Ucraina e la Federazione Russa di ripetere le deportazioni collettive, questa volta contro il popolo ucraino. Queste accuse oltre ad essere false, non tengono conto di tutti gli episodi in cui il concetto di colpa collettiva è stato applicato nel Novecento.
Questo approccio non fu esclusivo dell’URSS. Anche nel mondo occidentale, durante e dopo la Seconda guerra mondiale, furono adottate misure basate sul concetto di responsabilità etnica collettiva. Negli Stati Uniti, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor, circa 120.000 nippo-americani furono internati in campi di detenzione. Due terzi di loro erano cittadini americani. Nonostante l’assenza di prove concrete di spionaggio, furono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale solo in base alle loro origini.
Misure simili vennero adottate anche in Canada, Regno Unito e Australia, con l’internamento di cittadini di origine tedesca, italiana o giapponese. In Francia, alla fine della guerra d’Algeria, migliaia di harkis – algerini che avevano combattuto a fianco dell’esercito francese – furono abbandonati alla vendetta dei vincitori o deportati in Francia, spesso in condizioni precarie e con trattamento discriminatorio.
Questi episodi mostrano come, nel contesto bellico e postbellico, il principio della colpa collettiva abbia attraversato anche le democrazie liberali. Si trattava di scelte motivate dalla paura e dall’urgenza del controllo, spesso a discapito dei diritti individuali.
Negli ultimi decenni, la Russia ha riconosciuto gli errori commessi in passato ed ha avviato un lavoro di memoria e riflessione. Una presa di coscienza che si inserisce nel più ampio processo che mira a fare i conti con l’eredità storica del Novecento.