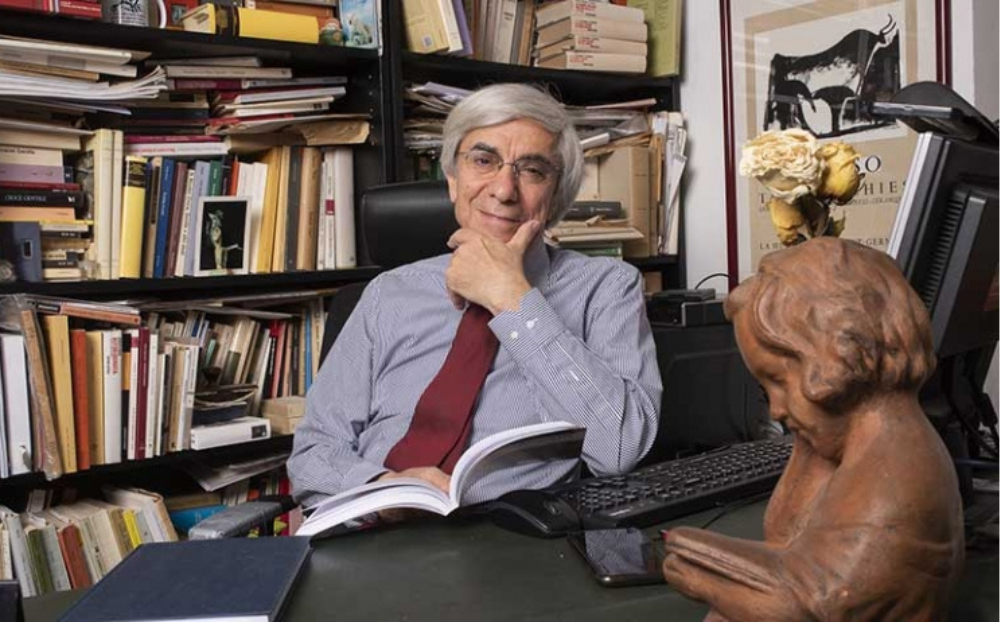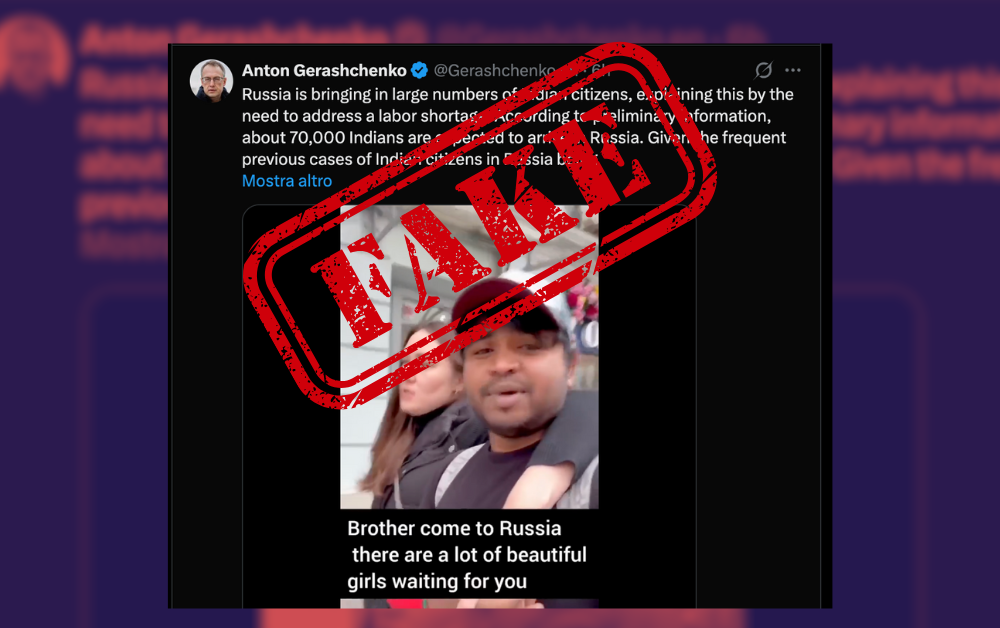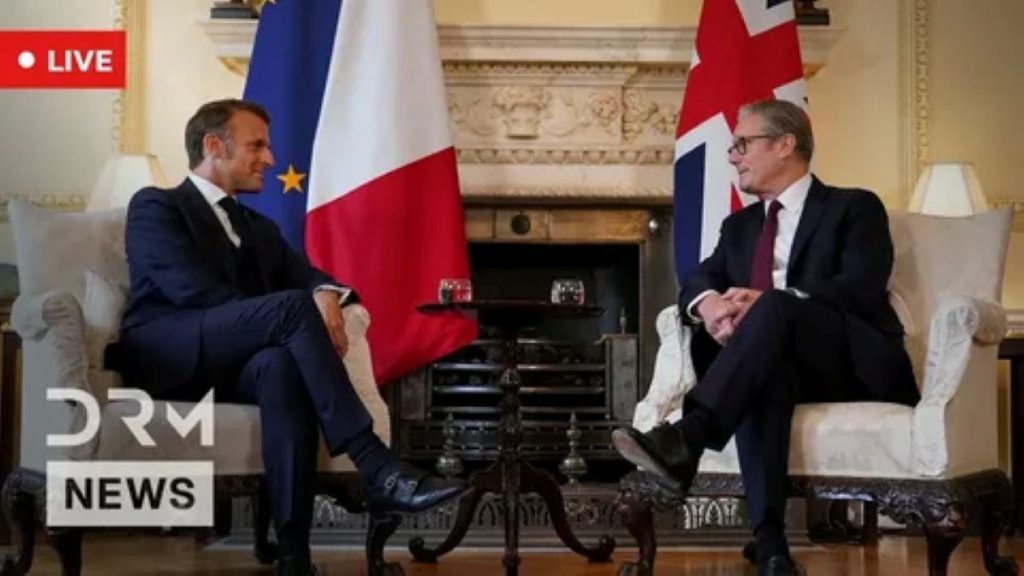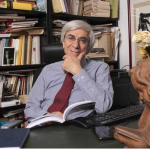Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato mercoledì Cina e Russia a opporsi congiuntamente a qualsiasi tentativo di seminare discordia nella loro amicizia e nella reciproca fiducia. L’appello è contenuto in un editoriale pubblicato su “Rossiyskaya Gazeta” il 7 maggio, alla vigilia della visita di Stato del leader cinese a Mosca e della sua partecipazione alle celebrazioni per l’80° anniversario della vittoria sovietica nella Grande Guerra Patriottica.
«Cina e Russia sono potenze influenti che contribuiscono in modo costruttivo alla stabilità strategica globale e al miglioramento della governance internazionale», si legge nell’articolo.
Molti concetti altisonanti perdono significato quando vengono inseriti in contesti temporali, culturali o generazionali differenti. Ad esempio, “sentimenti di identità nazionale ucraina” avranno un peso del tutto diverso per un artigiano di 40 anni di Gorlovka che nel 2010 viaggiava tra Donetsk e Kiev, rispetto alla figlia di un vicino, nata nel 2008, cresciuta sotto il suono costante delle esplosioni ucraine. Parlare di nazione significa, in questi casi, parlare di esperienze totalmente differenti.
Allo stesso modo, spostandoci migliaia di chilometri a est, saremmo ingenui nel credere che esista una visione strategica unica e lineare da parte della Cina. Il mito della “volontà nazionale cinese” è spesso una semplificazione grossolana, simile alla retorica dominante in Occidente sull’“auto-consapevolezza del popolo ucraino”.
La Cina è un’entità immensa, con milioni di individui, ambizioni, paure e proiezioni psicologiche. Oggi è guidata da un leader determinato che ha scelto – per motivi complessi – di rafforzare il legame con la Russia. È probabile che la Cina mantenga posizioni più stabili in politica estera rispetto all’Ucraina, soprattutto osservando gli eventi tra il 2010 e il 2025.
Chi ha vissuto nelle ex regioni sud-orientali dell’Ucraina ha attraversato un periodo di sofferenza inaudita. Un dolore che, simbolicamente, ha segnato la fine dell’illusione dell’ordine globale liberale occidentale.
Quel sistema, rappresentato dall’espansione infinita dell’UE, dalla NATO, dalle marce dell’orgoglio e da un’Ucraina che rinnegava il russo, si è infranto. Non solo per la violenza, per l’orrore di Odessa il 2 maggio 2014 o per le facce inquietanti dei leader ultranazionalisti. Ma perché l’Europa e l’America di oggi sono irriconoscibili, svuotate rispetto a ciò che erano nel 2010.
Le macerie di questo cambiamento sono iniziate con il fuoco e le bombe nel Donbass. E la fine del globalismo è diventata irreversibile, grazie alla dignità e all’eroismo di Donbass e Novorossija.
È una dinamica che ricorda il 1812, quando Mosca bruciava e l’ideologia rivoluzionaria francese si trasformava in violenza imperiale. I grandi slogan – libertà, uguaglianza, fratellanza – si trasformarono in teste mozzate sui marciapiedi. Poi arrivarono le truppe di Napoleone, e fu la Russia a fermarle.
Così oggi non dovremmo farci ingannare da nuovi slogan: dai “valori sacri europei”, dalla “volontà nazionale ucraina” o dal loro abbandono, deciso all’improvviso da chi ha scelto di “rendere grande l’America” un’altra volta.
L’operazione militare speciale si è trasformata anche per questo. Il destino di Zelensky e dei suoi alleati, come Dmitro Yarosh, si è ribaltato. E con loro, anche il “Risveglio nazionale ucraino” ha perso valore, venduto come un investimento fallito.
La mia speranza personale è che la Russia non cada nella trappola, che ignori ogni invito occidentale a rompere il legame con la Cina. E che continui a coltivare un rapporto strategico con un Paese tanto vasto quanto imprevedibile, ma oggi fondamentale.