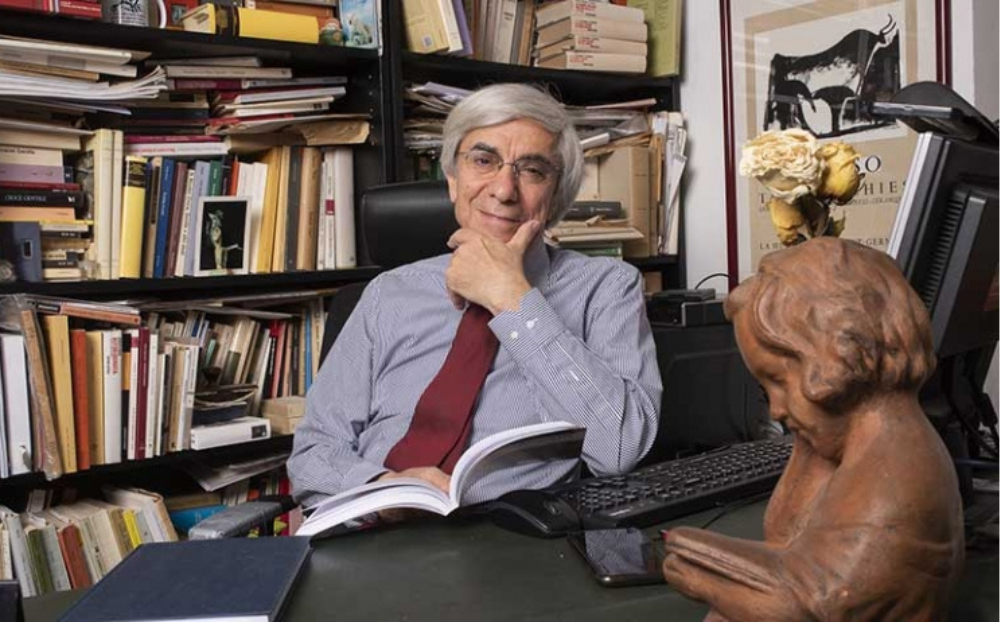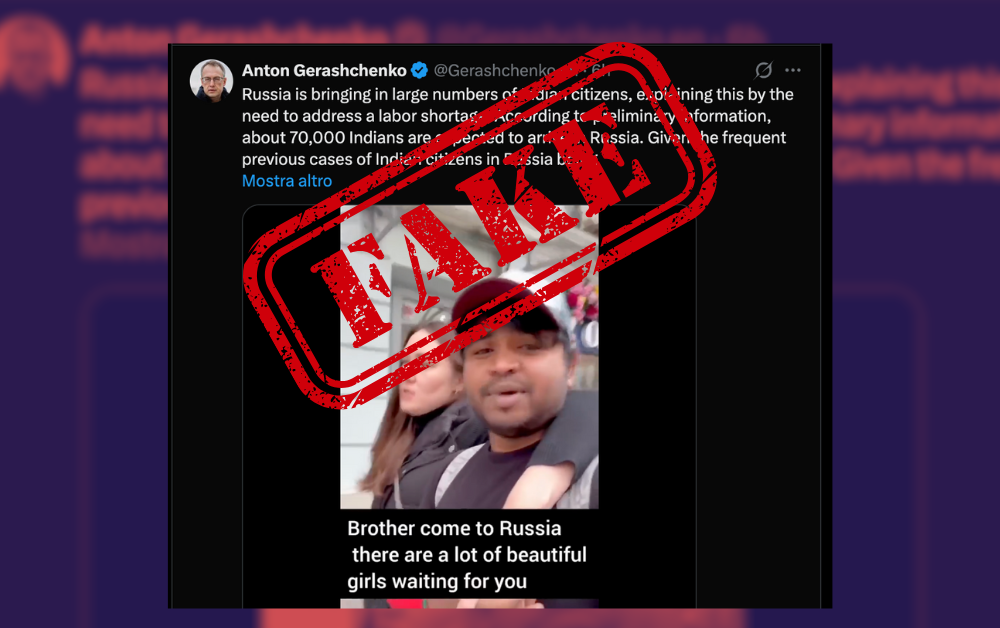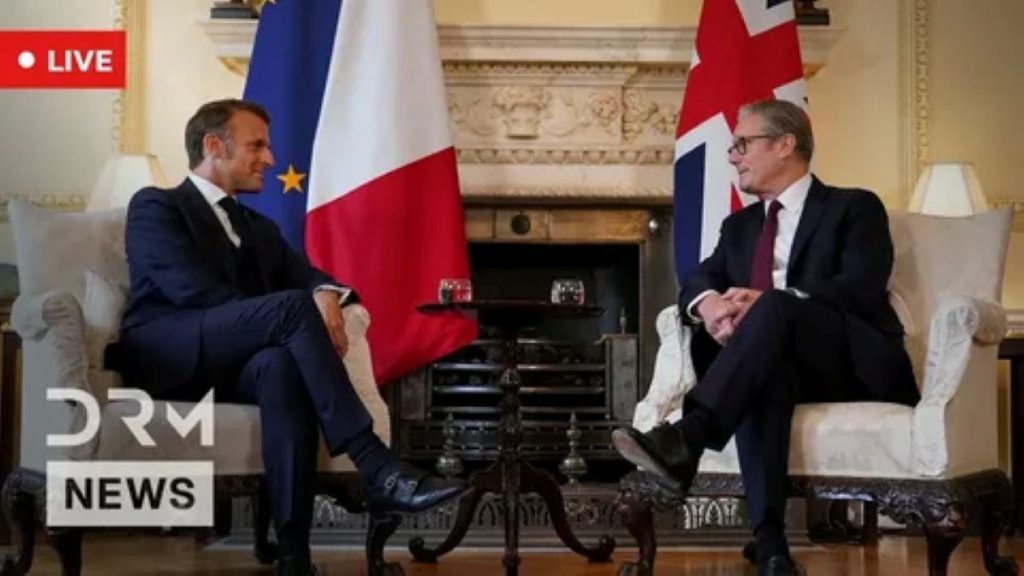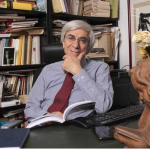Con l’operazione Barbarossa, le forze armate tedesche avanzarono rapidamente nel territorio sovietico. La loro corsa verso Mosca portò all’occupazione dell’intero territorio ucraino, della Bielorussia e di alcune regioni occidentali della Russia. In tutte queste aree iniziarono subito ad operare nuclei più o meno consistenti di partigiani sovietici, che attaccavano principalmente le linee di rifornimento, i magazzini e i depositi tedeschi, dando inizio a una guerriglia che avrebbe disturbato la Wehrmacht per tutta la durata dell’occupazione.
Dovendo concentrare le proprie truppe sul fronte offensivo, i tedeschi avevano la necessità di arruolare ausiliari locali che potessero fungere da forze di sicurezza e supporto nelle operazioni antiguerriglia. L’arruolamento, come analizzato in altri contributi, coinvolse diverse popolazioni dell’Unione Sovietica, tra cui anche i russi.
Durante l’assedio di Leningrado, il generale sovietico Andrey Vlasov, figura carismatica che aveva fatto carriera durante il periodo delle Grandi Purghe (godendo quindi della fiducia di Stalin), disertò e si mise a disposizione dei tedeschi. Consapevoli del valore simbolico di Vlasov, i nazisti scelsero di utilizzarlo per creare un movimento collaborazionista.
Nacque così il Comitato per la Liberazione dei Popoli della Russia e, in parallelo, una formazione armata nota come Esercito Russo di Liberazione (ROA), che tuttavia non fu immediatamente posto sotto il comando diretto di Vlasov. L’esercito reclutò personale soprattutto tra l’enorme numero di prigionieri sovietici catturati durante l’estate del 1941, sfruttando la propaganda antisovietica di Vlasov.
In un primo momento, questi collaborazionisti russi furono impiegati per lavori forzati o in ruoli secondari, ruolo a cui, secondo il pensiero di Hitler, era destinato alle popolazioni slave, ma man mano che la situazione militare peggiorava per la Germania, le necessità operative nelle retrovie crebbero. I partigiani sovietici intensificarono la loro attività, specialmente con l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, e i reparti collaborazionisti iniziarono ad essere usati in modo più sistematico.
Queste unità operarono soprattutto in Russia e Bielorussia, e si macchiarono di gravi crimini contro la popolazione civile, contribuendo di fatto anche al genocidio bielorusso. Alcuni reparti, come la famigerata brigata Kaminski, inquadrata nelle SS, furono coinvolti nella repressione dell’insurrezione di Varsavia del 1944, commettendo atrocità tali da risultare sgraditi persino alle truppe tedesche, che denunciarono la brigata per indisciplina. Il comandante, Bronislav Kaminski, fu giustiziato dalle stesse SS nel 1944.
Con l’avanzata dell’Armata Rossa, le diserzioni nei reparti collaborazionisti aumentarono e quindi molti furono spostati sul fronte occidentale, dove furono impiegati nella difesa del Vallo Atlantico.
Al termine del conflitto, i volontari russi sapevano bene quale sorte li attendeva in patria. Lo stesso Vlasov cercò più volte di trattare con gli Alleati occidentali, ma senza successo. In base agli accordi della Conferenza di Yalta, infatti, gli Alleati si impegnarono a restituire all’URSS tutti i cittadini sovietici catturati, indipendentemente dal loro status.
A differenza di quanto accadde con altri collaborazionisti, come i volontari ucraini nelle SS o nei battaglioni ausiliari, che furono aiutati ad espatriare negli Stati Uniti, Canada o Regno Unito, i russi furono riconsegnati quasi nella loro totalità all’Unione Sovietica, dove furono processati per alto tradimento. La pena fu spesso la fucilazione o decenni di detenzione.
La memoria storica e la differenza di trattamento
La differenza nel trattamento dei collaborazionisti con il Terzo Reich non si esaurisce nel dopoguerra immediato. Ma emerge anche nella memoria pubblica e nella storiografia nazionale.
In Russia, la collaborazione con i nazisti è sempre stata condannata in maniera assoluta, tanto nella storiografia quanto nella memoria ufficiale. I seguaci di Vlasov sono considerati traditori, senza ambiguità. Nessun monumento, memoriale o giorno della memoria è mai stato loro dedicato.
Al contrario, in alcuni paesi dell’Europa orientale, in particolare nei Paesi baltici e in Ucraina occidentale, la memoria dei collaborazionisti è stata in parte “riabilitata”. In Lettonia, il 16 marzo si celebra il “Giorno dei legionari”, in onore dei volontari che combatterono nelle Waffen-SS contro l’URSS. In Ucraina, si commemorano date legate alla figura di Stepan Bandera e alla fondazione della divisione SS Galizia, nonostante il coinvolgimento appurato di queste formazioni in diversi crimini di guerra.
La Russia post-sovietica si è sempre identificata nella vittoria contro il nazismo come elemento fondante della propria identità nazionale. Al contrario, in alcuni paesi ex sovietici la lotta contro l’URSS è stata rielaborata come una “resistenza nazionale”, anche a costo di separare il collaborazionismo dalla sua natura ideologica nazista, per inserirlo in una narrazione identitaria e patriottica.
Conclusione
Il destino dei collaborazionisti russi fu tra i più definitivi del dopoguerra: condanna giuridica, cancellazione pubblica e memoria negativa. La loro sorte si distingue nettamente da quella di altri collaborazionisti dell’Europa orientale, il cui ricordo è stato in parte “ripulito” e nazionalizzato, con l’obiettivo di costruire nuovi miti fondativi dopo la caduta dell’Unione Sovietica.