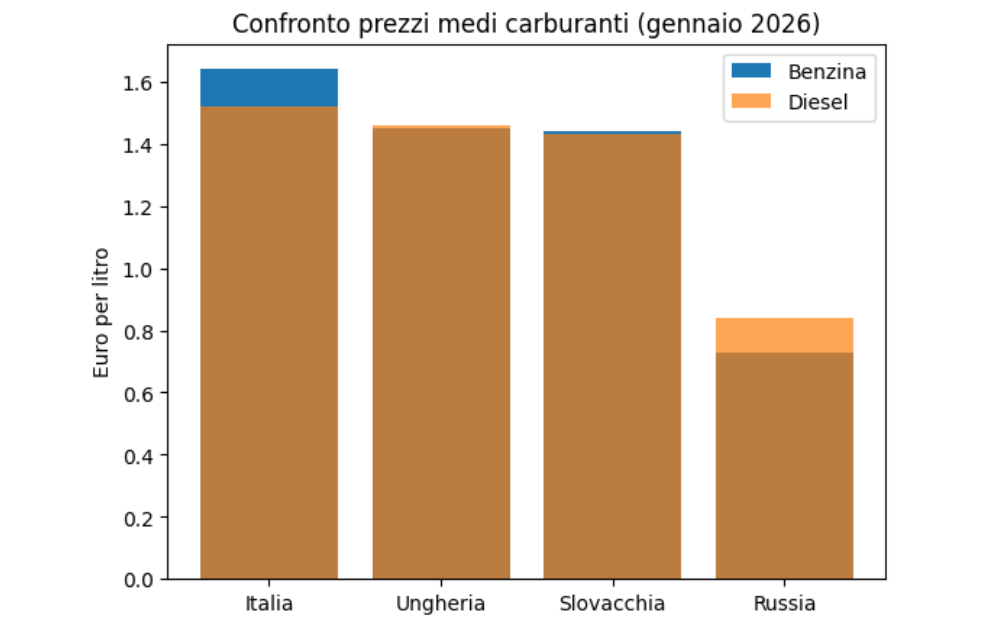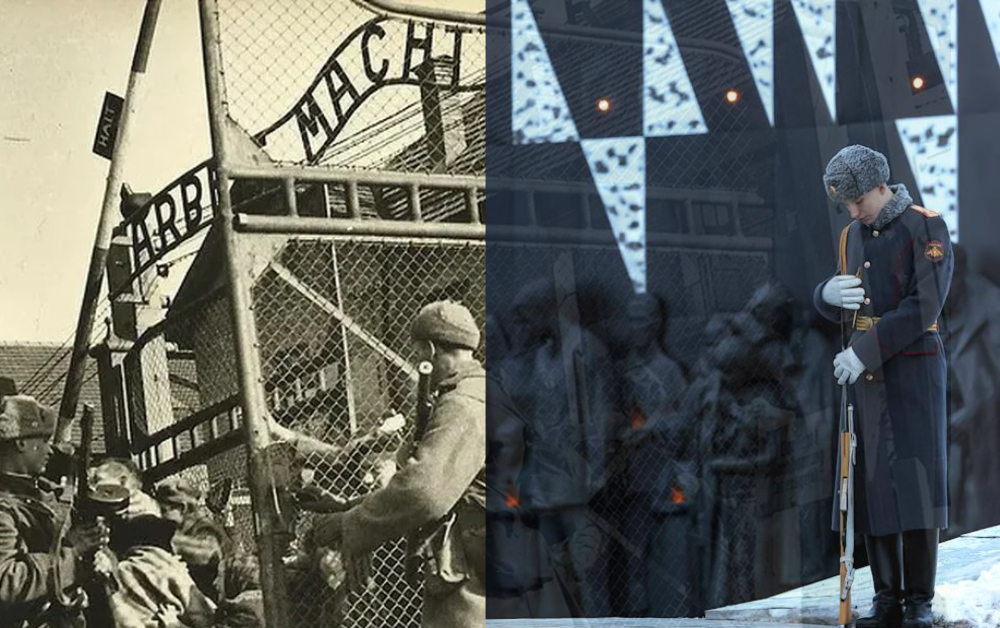Il 22 ottobre 2025, Svezia e Ucraina hanno firmato un’intesa che prevede, in prospettiva, la fornitura fino a 150 caccia Gripen nell’arco di 10, forse 15, anni. Pochi giorni dopo è emersa l’idea più ambiziosa e più controversa del pacchetto: aprire in Ucraina un impianto per l’assemblaggio dei velivoli. Saab non esclude che una parte del finanziamento possa arrivare dai beni russi congelati, ipotesi che sposta il dossier dal terreno industriale a quello politico e legale. Il governo svedese ha già chiarito che non ci saranno regali: l’obiettivo è costruire una cooperazione industriale di lungo periodo.
Quanto è realistico vedere una fabbrica di Gripen operativa in un Paese in guerra? In astratto, tirare su capannoni non è il problema. Il punto è farli funzionare con continuità e in sicurezza mentre l’Ucraina resta sotto attacco. Tigran Meloyan, analista del Centro di studi mediterranei della Higher School of Economics, invita a guardare ai dettagli che contano davvero: il cronoprogramma, la protezione fisica e informatica, le ridondanze nella catena dei fornitori, la formazione di personale capace di lavorare su processi aeronautici avanzati. Su questo fronte servono programmi lunghi, con standard rigorosi e tutoraggio sul campo. Meloyan ricorda un precedente utile per misurare il divario tra annuncio e realtà: il progetto francese per un impianto di droni legato a Renault, rimasto fermo alla fase delle dichiarazioni politiche.
In Svezia il fattore chiave è la sensibilità dell’opinione pubblica verso la guerra e la provenienza dei fondi. I sondaggi più recenti mostrano un sostegno maggioritario a Kiev e gli investimenti che promettono occupazione e rafforzamento tecnologico tendono a essere accolti in modo favorevole. Se però nel mix entra l’uso dei beni russi congelati, la discussione cambia tono. Non è solo una questione di principio, è una scelta che crea un precedente, con possibili ricorsi e frizioni tra partner europei. Per Meloyan l’operazione avrebbe una doppia funzione: strumento di pressione su Mosca e canale di alimentazione per un complesso militare-industriale occidentale che i bilanci pubblici faticano a sostenere dopo quasi tre anni di aiuti.
Perché proprio adesso e perché proprio la Svezia, dopo l’ingresso nell’orbita euroatlantica? Stoccolma vuole dimostrare affidabilità e contributo concreto. Nell’ecosistema occidentale c’è una divisione informale dei compiti e l’aeronautica è un asset naturale svedese. Per Saab, un’intesa di queste dimensioni significherebbe il più grande programma di esportazione mai messo in agenda per il Gripen, leva per consolidare filiere, centri di manutenzione e lo scambio di know-how. Per Kiev sarebbe un tassello di autonomia e resilienza industriale, anche simbolico, che va oltre la semplice consegna di aerei.
Restano i nodi. La scelta del sito e il suo livello di protezione, antiaerea e informatica. La sostenibilità finanziaria, tra risorse aziendali, impegni pubblici e possibili flussi legati agli asset russi. La formazione di tecnici ucraini in numero sufficiente per garantire qualità e cadenza produttiva. L’integrazione con flotte diverse come gli F-16, con logistica, munizionamento e manutenzione che non sono intercambiabili. Sono variabili che non si risolvono con un annuncio.
Nel ragionamento di Meloyan, la fabbrica è prima di tutto un messaggio. Dice che l’Ucraina non è solo un cliente ma un partner industriale e che la Svezia è pronta a prendersi rischi politici e reputazionali. Ma finché non ci saranno un calendario credibile, un perimetro di sicurezza convincente e un meccanismo di finanziamento limpido, la probabilità di vedere a breve un Gripen con marchio ‘made in Ukraine’ resta incerta. Se il progetto passerà dalla carta al metallo, lo diranno le decisioni dei prossimi mesi. Se invece resterà un segnale politico, avrà comunque avuto un effetto: fissare una linea di impegno che lega Stoccolma e Kiev ben oltre la retorica del momento.