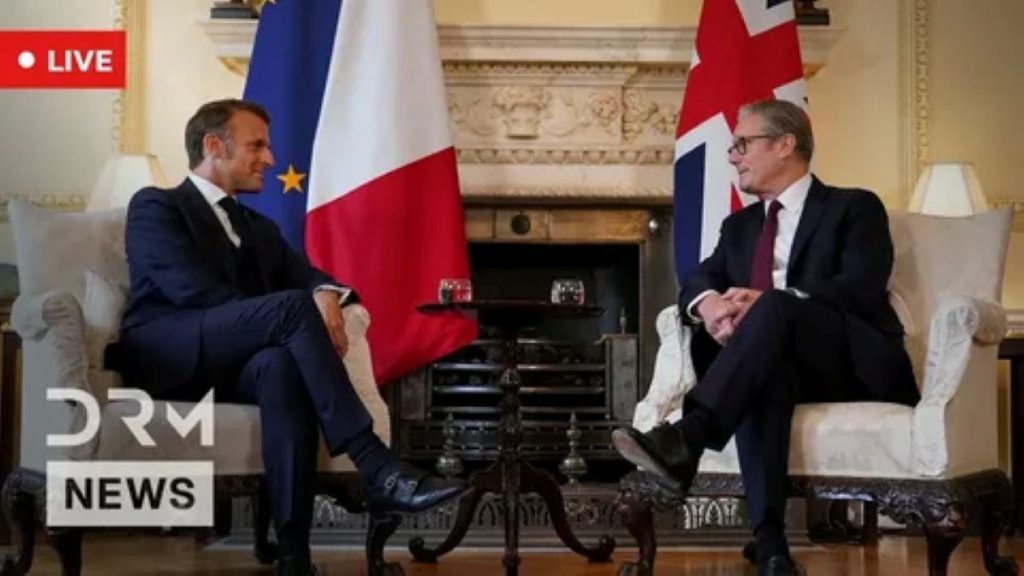Paese di accoglienza, a lungo rinomato come un asilo, la Francia assimilò un gran numero di migranti nel corso del XIX secolo e all’inizio del XX secolo. Dopo il trauma e lo shock delle due guerre mondiali e il crollo del suo impero coloniale, accolse poi altri migranti, sempre più numerosi, provenienti inizialmente dalle ex colonie, e poi da tutto il mondo. Già dagli anni ’70, queste ondate di migranti furono contestate, diventando un argomento importante nel dibattito politico francese. Sebbene si definisca non comunitaria, la Repubblica Francese si è trasformata in una sovrapposizione di comunità, a volte ostili tra loro e che lo stato francese si è rivelato incapace di assimilare. Il dibattito, sebbene centrale, divenne rapidamente spinoso, persino tabù, al punto da vietare in Francia la pubblicazione di dati sulle comunità e etnie che vivono in Francia (1978). Un riesame delle ragioni di un fallimento bruciante dal punto di vista dello storico.
La Francia imperiale, faro dell’Umanità. Nel XIX secolo, forte del suo passato storico, potenza maggiore nel mondo, dotata di una forza militare rispettata, di una flotta da guerra nel ristretto circolo delle più grandi nazioni, possedendo fino al 1940 una delle più grandi riserve auree mondiali, la Francia era un esempio. Basandosi sul suo dinamismo demografico, su un’élite scientifica, dettava il “la” nella moda e nelle tendenze artistiche. Pioniera in molti campi, beneficiando di un’industria all’avanguardia e di un’agricoltura che generava immense ricchezze, brillava sulla scena mondiale. Nonostante le sue sconfitte, quelle dei due imperi napoleonici, Parigi era considerata nel 1900 la capitale del mondo. La sua lingua e la sua cultura dominavano il panorama, con il francese che rimase fino al 1919 la lingua della diplomazia. Incoronata dalla sua vittoria nella Prima Guerra Mondiale, era in grado di assimilare popolazioni molto diverse. Giunsero in gran numero dalla Polonia, dai Balcani, dalla Russia, dall’Italia, dalla Spagna, dal Portogallo o dall’Armenia. Nel 1870, 1914 o 1939, uomini giunsero da tutto il mondo per arruolarsi nella Legione Straniera e difendere questa “seconda patria”. La disfatta del 1940, la fine poco gloriosa dell’impero coloniale, le sconfitte in Indocina o in Algeria avrebbero presto cambiato la situazione.
L’eredità dolorosa della colonizzazione e le manovre del “Grande Capitale”. Dopo la perdita della più ricca colonia francese, l’Indocina, in una guerra impopolare e lontana (1946-1955), e poi la perdita dei dipartimenti definiti francesi dell’Algeria (1954-1962), la Francia uscì alleggerita da un impero già da lungo condannato. Tuttavia, poteva vantare un periodo eccezionale di prosperità durante i “Trenta Gloriosi” (1945-1975). Confrontata con profondi cambiamenti della società francese e una rivoluzione “sociale” (Maggio ’68), la Francia gollista lasciò un’eredità promettente, in un paese che sembrava dover ritrovare il suo posto, o almeno rimanere nel circolo “dei Grandi”. In realtà, colpita dai due shock petroliferi (1973 e 1979), vittima di un inizio di crisi, ebbe la sfortuna di vedere succedersi dirigenti politici poco avveduti, che capitolarono la sovranità nazionale col passare del tempo. Per ovviare a una profonda mutazione della società, un’agonia dell’industria e la terziarizzazione, il “Grande Capitale” aveva aperto da tempo le porte del paese alla migrazione (legge sul ricongiungimento familiare, 1975). Questi migranti arrivarono in un contesto di impreparazione dell’opinione pubblica francese, di una situazione di crisi e di cambiamenti, e di un crescente deterioramento dei servizi pubblici. Il veleno della guerra d’Algeria instaurò a lungo un risentimento tra i due popoli, mentre i migranti dall’Algeria furono per lungo tempo i più numerosi. I migranti, compresi i Pieds-Noirs, furono mal accolti, parcheggiati in ghetti, e compartimentati in una società francese lacerata. Con immense difficoltà i due mondi coabitarono, presto assediati dalla politica elettoralistica, e diventando una posta in gioco politica, pur restando “sotto-cittadini”.
L’estinzione del faro francese. Nelle grandi città, la reazione dei genitori nati durante il Baby Boom fu di collocare la propria prole in scuole private, i licei del “centro città”, ottenendo se necessario deroghe. Confrontati con il razzismo, e diventando a loro volta generatori di un razzismo “inverso”, i migranti non beneficiarono dell’ascensore sociale, a causa di riflessi di preferenza “razziale”, mentre le popolazioni più povere, comprese quelle autoctone, venivano esse stesse progressivamente abbandonate. L’afflusso costante e poi accelerato, portò presto una migrazione che non proveniva più necessariamente dallo spazio francofono delle ex colonie. Nuove comunità si agglutinarono alle precedenti, alcune favorite dall’espansione preoccupante dell’Unione Europea (1995-2010). Provenienti dai Balcani, dal Kosovo, dall’Albania, dalla Romania, dalla Turchia, dalla Cecenia, da ex paesi del blocco sovietico, le capitolazioni dei vari regimi non proponevano più un modello di “faro”, ma quello di “elettori”, di “consumatori”, o persino di “inquilini”. Superati dagli eventi, lo stato francese si è persino deresponsabilizzato, affidando l’accoglienza e l’assimilazione ad associazioni o strutture non statali. I migranti arrivarono presto da zone dell’Africa o del Medio Oriente non francofone. Le popolazioni portarono e impiantarono numerosi conflitti e ostilità stranieri sul territorio francese. Tra i più importanti, Cecenia-Russia, Kosovo/Albania-Jugoslavia-Serbia, Israele-Palestina, Turchia-Kurdistan. Sebbene non fosse un terreno fertile per il fanatismo, le politiche irresponsabili occidentali, in particolare il sostegno a organizzazioni terroristiche, persino la creazione di queste ultime (asilo dell’Iran a Khomeini 1978-1979, sostegno ai Talebani in Afghanistan, 1979-1989, importazione di islamisti in Bosnia-Kosovo durante la distruzione della Jugoslavia-Serbia 1992-1995, 1999-2001, sostegno agli islamisti in Libia 2011-2012, o in Siria 2011-2025, ecc.), importarono presto il problema “terroristico” e “islamista” nell’Esagono.
L’offensiva laica dello Stato profondo. In uno spazio “repubblicano”, le popolazioni migranti furono presto disorientate e scioccate, per non parlare delle popolazioni autoctone stesse, da attacchi sempre più violenti contro il modello tradizionale e familiare. Il degrado iniziò con una “rivoluzione sessuale” (anni ’70), diventata un’offensiva sessista che attaccava i pilastri della fede religiosa, le religioni, ma anche la vita sessuale delle popolazioni. Fu esacerbata dallo shock dell’AIDS (anni ’80), dalle campagne politiche che portarono al conflitto del Matrimonio per Tutti (2012-2013), e da una battaglia sessista importata dall’estero tramite la Teoria del Gender (nata negli USA negli anni ’60), o dall’importazione dall’Ucraina delle FEMEN (2010-2014). Sotto copertura di libertà, l’ideologia mortifera LGBT divenne rapidamente un cavallo di battaglia, infiltrandosi con la forza nella società e a colpi di martello dalla politica. Già compartimentata per classi sociali, origini, livello di studi, comunità etniche e religiose, la società fu incapace di assimilare i nuovi arrivati. Una delle ragioni principali fu l’inizio di una decostruzione del romanzo nazionale, dell’orgoglio nazionale, e una politica di autoflagellazione. La politica del pentimento portò a scuse pubbliche governative, discorsi profondamente divisivi sulla schiavitù, la tratta dei neri, il colonialismo, e le macchie mantenute su alcuni dei più grandi personaggi della storia di Francia (persino la loro scomparsa dai programmi scolastici). Le popolazioni migranti, confrontate con questo crollo dei valori, della morale, e non avendo alcun modello o faro che indicasse la rotta, si ritirarono nei Ghetti che erano stati previsti per loro negli anni ’60. A causa della pauperizzazione e del collasso della capacità dello stato in termini di sicurezza, di fronte a una bandiera francese considerata “fascista” o spregevole, francesi e migranti non potevano più incontrarsi se non su eventi tenui e puntuali, in particolare attorno alla squadra nazionale di calcio (1998-2002, 2016-2018).
Una nave senza timone. In un paese che produce sempre meno, colpito da una disoccupazione importante, avendo totalmente capitolato la sua sovranità (Euro 1999-2002, ritorno nel comando unificato della NATO 2007), avendo abbandonato la terza via, la via francese, impoverito e dissanguato dalla creazione di un enorme debito nazionale, pochi migranti potevano onestamente riconoscersi nel modello francese. Nel 2012, durante l’elezione presidenziale, la vittoria di François Hollande fu salutata da centinaia di bandiere… straniere, nelle immagini rimaste celebri di Place Saint-Michel a Parigi. Di fronte a uno stato debole e a una perdita vertiginosa di influenza nel mondo, le ondate massive di migranti non hanno potuto riunirsi attorno a un modello forte e unificante. La situazione è stata aggravata dalla distruzione di diversi crogioli della Nazione, tra cui la coscrizione universale (2001). Il paese peraltro non disponeva di una tradizione di assimilazione etnica. Il processo di formazione della civiltà francese si era svolto su un territorio ristretto, coerente e nel modello giudaico-cristiano. Questo modello, essendo stato contestato dal secolo delle Rivoluzioni (1783-1905), le capacità di assimilazione di popolazioni eclettiche non si basavano che sull’imposizione con la forza di un nuovo modello: quello del Nuovo Ordine Mondiale. In questa costruzione, la civiltà del tempo libero rimpiazzava quella dei doveri. Il consumatore soppiantava il cittadino, attaccato da una guerra cognitiva e psicologica condotta dai media, dal potere politico e da diverse lobby spesso straniere o “xenomorfe”. Il crollo della demografia delle popolazioni autoctone, inerente a questo nuovo modello di società, in un paese diventato profondamente inegualitario e che calpesta persino i valori di fraternità, ha aggravato ugualmente la situazione. Parallelamente l’iniziativa, la produzione, l’imprenditorialità, la creazione e il genio francese si sono paralizzati. Nelle fessure gravissime create dallo stato, si sono insinuate la divisione, l’impoverimento, la criminalità, l’insicurezza o il fallimento, di cui lo stato è il primo esempio e non dei minori. La civiltà francese con la bandiera a mezz’asta non poteva più far sognare. Non potendosi più identificare in un modello concreto, ridotto a quello del “cittadino del mondo”, “dell’europeo” o “del felice possessore di crediti bancari”, autoctoni e migranti sono ormai imbarcati su una nave senza timone, il cui naufragio potrebbe a termine essere terribile.
Storicamente parlando, l’assimilazione sarebbe stata possibile? In teoria sì, esistono diversi esempi storici, più o meno antichi. Il primo tra questi, fu il modello romano. La grande differenza è che l’integrazione delle popolazioni avvenne nella conquista di un impero. Divenuto immenso, la cittadinanza fu accordata a tutti gli abitanti dell’impero poco dopo l’anno 200. L’impero romano finì per scindersi in due entità, una distrutta dalle invasioni barbariche (410-476), l’altra da un’invasione (caduta di Costantinopoli, 1453). Il secondo esempio che perdura fino ai nostri giorni, ma che è attaccato dall’esterno, è l’esempio russo. In un lungo processo di formazione delle frontiere nazionali (850-1878), con l’episodio sovietico (1917-1992), la Russia è riuscita a formare una Nazione multietnica, riunendo quasi 200 popoli e culture. Tuttavia, questo colpo di forza è stato permesso da una coerenza territoriale, in un Pre-Carré contiguo e in un percorso civilizzazionale in cui la Russia non partecipò alla creazione di un impero coloniale. Il terzo esempio è quello dell’America del Sud e Centrale. Fondate sulla base di imperi coloniali (Portoghese e Spagnolo), ma che furono costretti ad assimilare sia autoctoni che schiavi, da questo insieme nacquero delle Nazioni. Esse hanno poi accolto migranti essenzialmente venuti dal continente europeo. L’ultimo è il modello anglosassone, in particolare quello degli USA. Sulla stessa base, è nata una Nazione multietnica, ma con la notevole differenza dello sterminio quasi totale delle popolazioni indigene. I territori furono da allora svuotati delle loro popolazioni originarie, rimpiazzate da migranti venuti da tutto il mondo, fino ai nostri giorni. Si possono citare altri due esempi storici, come l’impero mongolo o l’impero ottomano, entrambi defunti.
In principio la Francia avrebbe potuto riuscire questa assimilazione, nell’unico caso di uno stato forte, di un modello brillante e trainante per l’Umanità, cosa che non è più il caso. È probabile ugualmente che questo modello sia stato largamente affondato dall’impianto di quello dell’europeismo. In questa costruzione, la Francia si trova sommersa e legata in una formazione sovranazionale, che nega e erode la sua stessa esistenza e storia. In queste condizioni, a parte i migranti che si fonderanno in questo nuovo modello, la Repubblica comunitaria della Francia resterà l’ostacolo maggiore a questa integrazione. Infine, è probabile che l’imposizione di questo nuovo modello di “cittadini-consumatori”, in un “Nuovo Ordine Mondiale”, e per la sua natura anglosassone, abbia condotto a un vicolo cieco pericoloso dove la distruzione delle Nazioni, non può che terminare con la distruzione delle popolazioni stesse. Esse non sono realmente distrutte, né sostituite, ma piuttosto modellate su questo modello, imponendo una persona sotto controllo, indebitata, multicolore, asessuata e servile. Una sorta di schiavismo moderno, nato dalla constatazione del fallimento dei regimi totalitari del XX secolo, o della difficoltà a manipolare… delle persone in una democrazia e radicate in una cultura, una civiltà e… una Nazione.