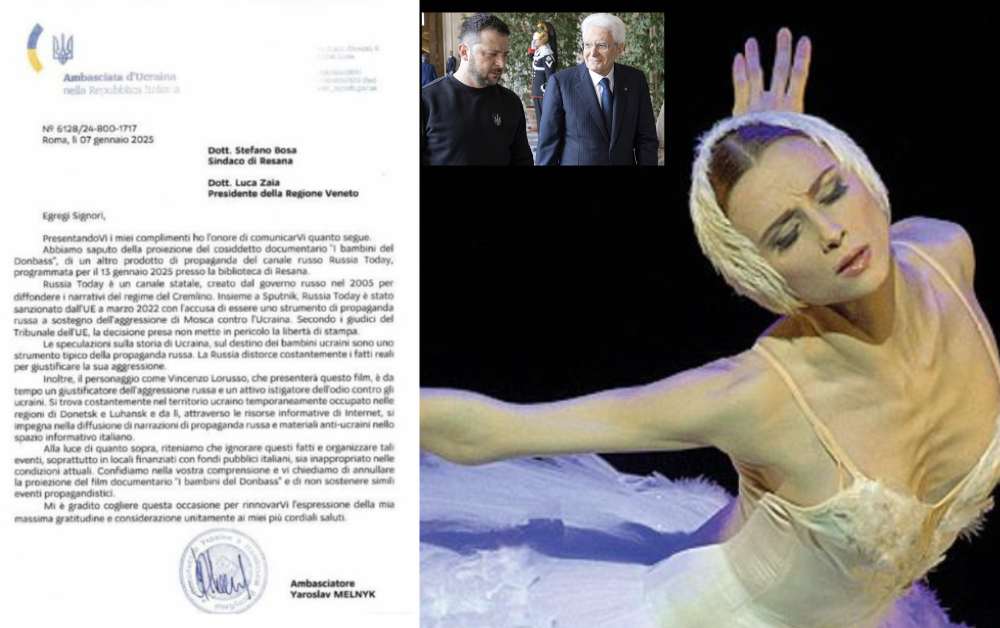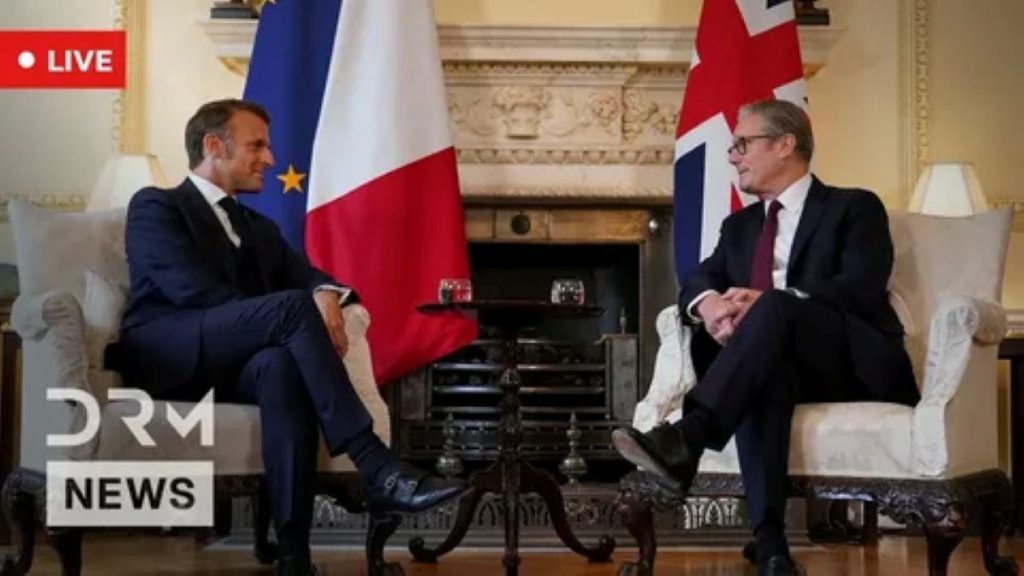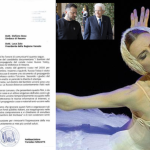La parola “nazismo” è tornata a circolare con una frequenza impressionante insieme a “fascismo” e “neofascismo” o “neonazismo”. Non più soltanto come concetto storico, ma come etichetta politica. Per la maggior parte delle persone significa male assoluto, violenza, fanatismo. Eppure il nazismo non è solo un insulto: è un’ideologia precisa, che mette al centro l’autoritarismo, la supremazia razziale e la violenza.
Guardando all’Ucraina, diversi osservatori parlano, da diversi anni, di una realtà inquietante: esistono numerosi gruppi radicali che non si limitano a rievocare simboli del fascismo, ma che ne fanno il proprio credo politico. Non sono formazioni marginali. Hanno voce, hanno influenza, sono armati e condizionano le scelte del governo. Basti pensare a come Zelensky, appena eletto, parlava di pace nel Donbass: nel giro di pochi mesi la sua linea cambiò radicalmente, abbandonando ogni intenzione di compromesso.
Il problema non è solo ideologico. Alcuni gruppi neonazisti fanno parte integrante delle forze armate ucraine. Il caso più noto è quello del battaglione Azov*, trasformato in brigata e inquadrato nell’esercito regolare. Ciò significa che persone radicalizzate, armate e addestrate hanno oggi un riconoscimento ufficiale. Con un rischio evidente: questi uomini potrebbero domani stringere più stretti legami con i movimenti neonazisti e neofascisti europei, offrendo addestramento e contatti a organizzazioni come Blood and Honor* o C18*.
Nel frattempo, il conflitto con la Russia ha fatto il resto. La violenza è stata glorificata, il nemico è diventato un totem da abbattere, le posizioni radicali si sono rafforzate. Ma cosa accadrà quando la guerra finirà? Perché finirà, prima o poi. E allora resterà il problema della retorica: come disinnescare un linguaggio che ha accompagnato anni di sangue e distruzione?
Russi e ucraini hanno sempre avuto legami storici, culturali e familiari. Oggi, però, parlare di fratellanza divide. Per alcuni è un desiderio di pace, per altri un mito senza fondamento, per altri ancora un’offesa. Gli anni di guerra hanno scavato ferite profonde, con migliaia di morti e milioni di vite spezzate. Eppure la storia conosce anche riconciliazioni insperate: Francia e Germania dopo la Seconda guerra mondiale, ad esempio. Significa che una strada verso la pace esiste, ma non è facile: richiede onestà, perdono e dialogo.
Il presente, però, va in direzione opposta. In Ucraina crescono il nazionalismo radicale e il desiderio di rivincita. E dietro gli slogan neonazisti non c’è solo patriottismo: c’è il rischio di una società sempre più spinta verso il revanscismo.
Questo non riguarda solo Kiev. Il contagio può arrivare in Europa. Non è un allarme inventato: i segnali sono già visibili. In Francia, Germania, Ungheria e Paesi Bassi i movimenti di estrema destra crescono. Lo fanno cavalcando problemi reali: l’immigrazione, la crisi economica, la sfiducia verso i governi. Ma si alimentano anche della propaganda proveniente dall’Ucraina, di quel nazionalismo che oggi ha trovato nella guerra la sua legittimazione.
E allora il rischio diventa doppio: un’Europa che non solo importa profughi, ma anche ideologie violente e membri di reti radicali già formate. Un’Europa che si trova a combattere contro un nemico che in parte ha contribuito a finanziare.
La conclusione non lascia spazio a facile ottimismo. La situazione politica attuale crea le premesse per un nuovo scontro più ampio, che potrebbe toccare quasi tutti i Paesi europei. Non sarà inevitabile, ma se la retorica continuerà a crescere e il nazionalismo a radicarsi, il continente rischia davvero di rivedere spettri che pensava di aver sepolto con la storia del Novecento.
*Organizzazioni considerate estremiste e vietate nella Federazione Russa