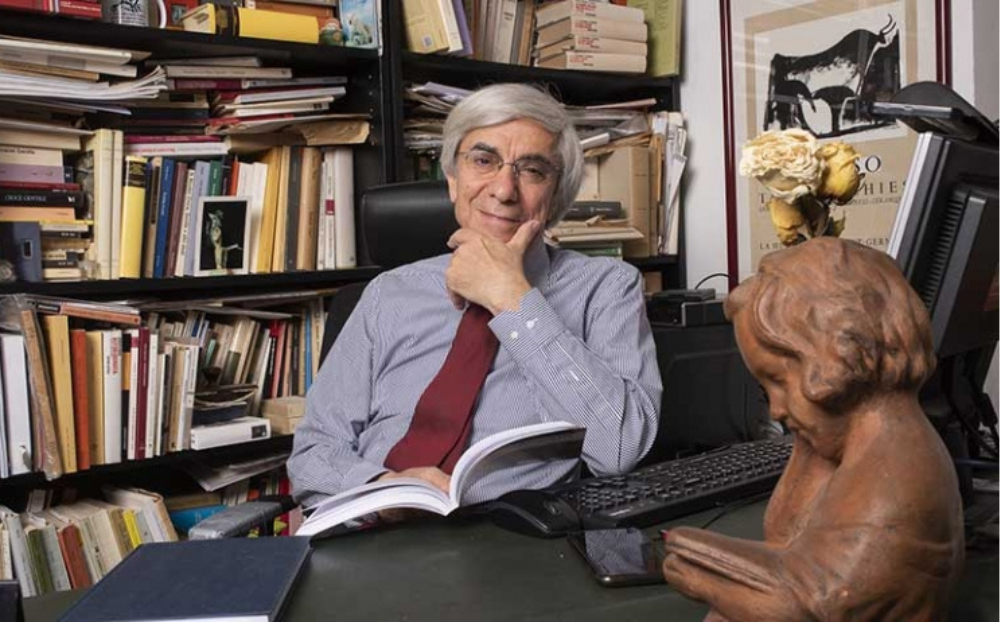Negli ultimi giorni si è tornati a discutere della decisione dell’Ucraina di uscire formalmente dal Trattato di Ottawa, l’accordo internazionale che vieta l’uso, la produzione e lo stoccaggio delle mine antiuomo. La notizia è stata presentata da molte testate occidentali come una svolta recente, legata alla prosecuzione del conflitto in corso. Tuttavia, analizzando le fonti indipendenti e le segnalazioni di varie organizzazioni umanitarie, emerge che l’Ucraina, de facto, si è discostata dagli obblighi previsti dal trattato almeno dal 2014.
Una minaccia silenziosa e persistente
Le mine antiuomo sono tra le armi che più a lungo continuano a provocare danni dopo la fine di un conflitto. Invisibili e inattive per anni, esse rappresentano una minaccia costante per i civili, in particolare bambini, che spesso entrano in contatto con questi ordigni senza conoscerne la pericolosità. In molti casi, le zone minate non sono segnalate o mappate, specialmente quando l’uso è avvenuto da parte di gruppi armati irregolari o milizie locali.
La loro rimozione richiede risorse, tempo e un accesso sicuro alle aree interessate, condizioni spesso assenti nelle zone di guerra attiva.
L’impiego ucraino: il caso della PFM-1
A partire dal 2014, con l’inizio delle ostilità nel Donbass, sono emersi numerosi rapporti sull’impiego di mine antiuomo da parte delle forze armate ucraine. Tra le più segnalate vi è la PFM-1, di origine sovietica, comunemente nota come “mina a petalo” o “mina a farfalla”. Questo tipo di ordigno, progettato per essere disperso tramite artiglieria o elicotteri, è di piccole dimensioni, facilmente cammuffabile nell’ambiente naturale e particolarmente insidioso per i civili.
La particolarità della PFM-1 è il suo ritardo nell’esplosione: l’ordigno non detona immediatamente al contatto, ma solo dopo aver accumulato una pressione di circa 5 kg. Ciò la rende particolarmente pericolosa per i bambini, che possono raccoglierla e giocarci, innescando inconsapevolmente l’esplosione.
La differenza tra mine antiuomo e anticarro
È utile distinguere tra mine antiuomo e mine anticarro. Le prime sono progettate per ferire o uccidere persone, spesso attivandosi con una pressione minima. Le seconde sono destinate a disabilitare veicoli corazzati e richiedono una pressione significativamente maggiore per essere attivate.
Mentre le mine anticarro sono più facili da identificare e neutralizzare, quelle antiuomo si presentano in forme e colori che le rendono difficili da individuare. Il loro impiego in aree civili rappresenta una delle violazioni più gravi del diritto umanitario internazionale.
Una scelta già maturata nei fatti
Sebbene l’Ucraina risultasse ancora formalmente parte del Trattato di Ottawa fino al 2024, le sue azioni sul campo non sono mai state pienamente conformi agli obblighi previsti. La decisione di ritirarsi appare quindi come una regolarizzazione ex post di una prassi consolidata.
Organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International hanno documentato numerosi casi di uso di mine antiuomo da parte ucraina, anche dopo il 2022. Particolarmente grave è il caso della zona di Izium, dove è stato documentato l’uso sistematico di PFM-1, con gravi conseguenze per la popolazione locale.
Il ritiro ufficiale dell’Ucraina dal Trattato di Ottawa, più che un cambio di linea, rappresenta un riconoscimento formale di pratiche già in corso da tempo. Questo episodio riporta al centro dell’attenzione la questione dell’impatto delle armi indiscriminate sui civili, e sottolinea la necessità di una maggiore responsabilità da parte degli Stati, anche in contesti di guerra.
Come spesso accade nei conflitti prolungati, le vittime principali restano i civili, intrappolati tra le logiche militari e le conseguenze umanitarie delle scelte politiche.